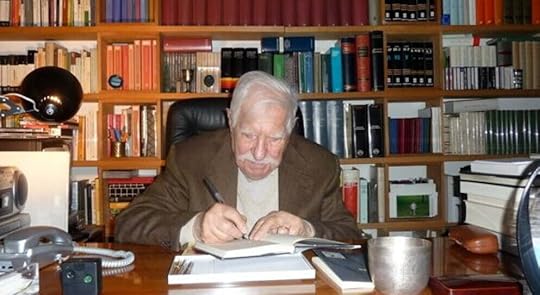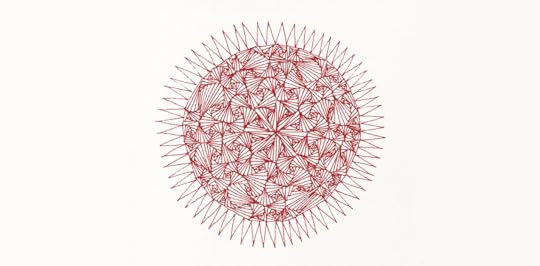Emanuele Trevi: La casa del mago. Ponte alle Grazie
“Era solo una storia - o meglio, un mito - che non smettevo di raccontarmi: quella di un ragazzino ancora inesperto della vita, non ancora, per così dire, venuto al mondo completamente. Perché nascere non basta…”
Ogni percorso di scoperta del Sé, ogni processo di Individuazione – vero scopo dell’esistenza di ogni essere umano, secondo Carl Gustav Jung – è un percorso iniziatico. Non può essere “studiato” o “appreso”: è un cammino di esplorazione interiore, un attraversamento profondo del proprio labirinto.
L’anima ferita incontra un guaritore, uno sciamano, che non dona la salvezza ma indica al viaggiatore l’esistenza di un giardino dimenticato, nascosto in una vecchia casa abitata durante l’infanzia. In quel giardino è sepolta una chiave. Trovarla, disseppellirla, individuare la serratura che quella chiave può aprire non è semplice. Ma una volta aperta la porta, si può accedere al proprio universo interiore ed esplorarlo senza perdersi, rimanendo – anzi – ben ancorati alla realtà.
Tutto questo, a volte, necessita di un innesco. E quell’innesco è spesso una perdita. Per Emanuele Trevi, è la morte del padre a rappresentarlo. La morte del mago.
“… Cosa fa esattamente un guaritore? Se c'è un potere che gli è indispensabile, è quello, tipicamente apollineo, di sciogliere - come diciamo che si scioglie un cane perché sia libero di correre in un parco. Tutti noi, chi più chi meno, abbiamo bisogno di essere sciolti: non solo dal falso destino che gli altri hanno scelto per noi (che sarebbe il meno) ma da quello (altrettanto falso) che noi stessi ci costruiamo intorno mentre viviamo…”
Mario Trevi, classe 1924, anconetano d’origine, laureato in Filosofia presso l’Università di Bologna, con un passato da partigiano e da insegnante di liceo, paziente prima e poi allievo dell’analista Ernst Bernhard, è stato uno dei capostipiti della scuola di psicologia analitica junghiana nel nostro Paese. Un interessante dialogo con il figlio Emanuele è rintracciabile nel volume scritto a quattro mani Invasioni controllate (Ponte alle Grazie). Muore a Roma nel marzo 2011.
Emanuele Trevi, scrittore e critico letterario, classe 1964, già direttore creativo di Fazi, nel 2012 si è aggiudicato il Premio Strega con Due vite, romanzo biografico dedicato agli amici Rocco Carbone e Pia Pieri.
La morte del padre lascia nelle mani di Emanuele e di sua sorella l’appartamento utilizzato dal terapeuta come studio. Un appartamento che sembra respingere ogni possibile acquirente: tutti concordano nell’avvertire un senso di disagio, forse dovuto a “un residuo potente di energia mentale, una specie di braciere psichico non ancora del tutto spento”. È in quella abitazione che Emanuele, il figlio, decide di trasferirsi.
L’ingresso nell’antro del mago segna per il protagonista il passaggio in una dimensione di confine, dove non sempre valgono le regole della realtà, ma in cui possono farsi strada intuizioni, sincronicità, coincidenze significative, capaci di ricomporre una trama nella quale non emerge più soltanto la figura di Mario, ma inizia ad acquisire spessore anche quella di Emanuele.
In alcune interpretazioni, nel sogno l’irruzione di una figura percepita come estranea – ladri, sconosciuti che penetrano nella propria casa – può essere letta come la manifestazione di una parte oscura di sé (l’Ombra, per restare nella terminologia junghiana) che preme per essere riconosciuta.
Nel testo di Trevi, l’Ombra assume le sembianze di una misteriosa visitatrice: possiede le chiavi dell’appartamento-studio, entra di notte, lascia tracce visibili.
A fare da moderne e scanzonate vestali sono le due figure femminili che frequentano l’abitazione: le cugine-amiche peruviane Rocio, detta la Degenerata – forse l’unica colf al mondo capace di lasciare in una casa “una patina uniforme di sciatteria, approssimazione, abbandono” – e Paradisa, amica e meretrice, con la quale lo scrittore instaura un rapporto di intimità fondato più sulla silenziosa compagnia che sul sesso.
La figura del padre sembra oscillare attorno a un fulcro di inconoscibilità e mistero, condensato in due frasi. La prima, pronunciata dalla moglie – “lo sai com’è fatto” (nella variante post-mortem “lo sai com’era fatto”) – è una formula che in realtà tutto dice e nulla spiega. Perché com’era fatto Mario, probabilmente, non lo sapeva nessuno. Introverso, poco incline a raccontarsi, allergico agli inviti e agli eventi mondani, riservato. Capace di estraniarsi dal mondo ed entrare in una dimensione personale, intima, protetta da un guscio difensivo quasi impenetrabile. Una frase che sancisce, dunque, l’accettazione di uno spazio privato irraggiungibile e, proprio per questo, non interpretabile.
La seconda frase è lo stesso Mario a pronunciarla, in un momento di delusione e frustrazione nei confronti del figlio, colpevole di un errore grossolano: da ragazzo, non avvisare i genitori di aver deciso di trascorrere due giorni con gli amici a Firenze, per ascoltare Lou Reed in concerto: “io non sono quello che credi”. In queste parole si rinviene la consapevolezza del filtro, della maschera indossata anche davanti alle persone più vicine.
La casa del mago si rivela così come il racconto – per flashback, frammenti di memoria, ricostruzioni, esperienze – di un rituale. Lo scrittore, riappropriandosi degli spazi dell’arte e dei contorni della figura paterna, da un lato compone il proprio romanzo familiare; dall’altro, attraverso un peculiare processo di elaborazione del lutto, traccia una rotta di allontanamento. Di differenziazione. Di nuova nascita.
Perché “nascere non basta, ogni tipo di destino impone che si nasca una seconda volta, e questa è una nascita notturna, un orientamento che in alcuni individui può essere decisivo verso l’ombra, l’oscurità, i tesori del buio”.