/ˈfɛʁnveː/ discussion
ventiventuno
>
letture ventiventuno
date newest »
newest »
 newest »
newest »
Naturalmente tutti parlano una lingua che non capisco, ma tanto qui non capisco quasi niente, e non so neanche cosa sono venuto a fare in Africa.
Ieri arrivando all’aeroporto di Bamako, ore 2.30 notturne, ho smesso di capire cosa stava succedendo. La confusione è cominciata appena siamo usciti dalle mani dei doganieri. Un vecchio con lunga zimarra azzurra, berretto copto, corpo secco, colore della pelle grigio perla, m’ha agganciato al varco. Parlava d’una navette, la corriera per andare a Bamako. Intorno c’erano ragazzi che mi tiravano per le braccia, altri che mi chiedevano come mi chiamo. Io avevo le orecchie che mi ronzavano, per cui confuso e mezzo sordo ho detto al vecchio che andavamo con la sua corriera. Il ragazzo Moussah entra subito in azione come aiutante del vecchio grigio e dice che per ritirare i bagagli ci vuole lo scontrino. Cosa ne so delle usanze di questo paese? Non so neanche dove s’è ficcato il mio socio, in mezzo al trambusto di gente accalcata in un camerone tipo caserma.
Comunque al ritiro dei bagagli e poi quando il ragazzo Moussah ci spingeva sulla corriera del vecchio grigio, ho capito che ormai eravamo legati a lui quasi per la vita. Trascinati attraverso lo spazio come nei sogni e nelle tempeste, vedo Moussah che respinge molti ragazzi accorsi per acchiapparci. Lui è arrivato primo e ha diritto di prelazione su di noi. Dopo in corriera si offende che ho già dimenticato il suo nome. Io tento di impietosirlo spiegando che il ronzio alle orecchie va avanti sempre e mi fa perdere molti suoni, ma niente da fare. I bagagli potevo benissimo ritirarli anch’io, nessuna formalità per il ritiro, a parte il fatto che tutti si facevano avanti a gomitate per acchiappare enormi cartoni o enormi valige, oppure sacchi di riso o tubature imballate o gomme di ricambio e uno persino una cassa con tre galline vive che s’era portato in aereo da Parigi.
Naturalmente tutti parlano una lingua che non capisco, ma tanto qui non capisco quasi niente, e non so neanche cosa sono venuto a fare in Africa. Nel tragitto verso Bamako ho visto soltanto la terra rossa alla luce dei fanali, le strade piene di buche come se avessero bombardato. La piccola corriera aveva dei traballamenti da aereo in un vuoto d’aria. Poi la sfilata di casettine, per lo più baracche, oppure tettoie di paglia, porte di negozietti chiusi, e sopra le porte nel buio quei piccoli tubi bianchi al neon, come quelli usati da noi nel dopoguerra. Ogni casetta o baracca con l’aria di un’anima persa nella savana, ognuna col suo lumicino da fiaba, tubo al neon di luce smorta e polverosa. Per il resto ero frastonato da Moussah che ogni due minuti mi chiedeva se sto bene, io dicevo di sì sempre meno convinto. Cercavo di spiegargli che avevamo bisogno d’un albergo, ma lui continuava a far domande sull’Italia, voleva sapere se conosciamo un certo Armando di professione sarto. Solo dopo m’è venuto in mente che parlava del famoso couturier Armani.
Avventure in Africa
Ieri arrivando all’aeroporto di Bamako, ore 2.30 notturne, ho smesso di capire cosa stava succedendo. La confusione è cominciata appena siamo usciti dalle mani dei doganieri. Un vecchio con lunga zimarra azzurra, berretto copto, corpo secco, colore della pelle grigio perla, m’ha agganciato al varco. Parlava d’una navette, la corriera per andare a Bamako. Intorno c’erano ragazzi che mi tiravano per le braccia, altri che mi chiedevano come mi chiamo. Io avevo le orecchie che mi ronzavano, per cui confuso e mezzo sordo ho detto al vecchio che andavamo con la sua corriera. Il ragazzo Moussah entra subito in azione come aiutante del vecchio grigio e dice che per ritirare i bagagli ci vuole lo scontrino. Cosa ne so delle usanze di questo paese? Non so neanche dove s’è ficcato il mio socio, in mezzo al trambusto di gente accalcata in un camerone tipo caserma.
Comunque al ritiro dei bagagli e poi quando il ragazzo Moussah ci spingeva sulla corriera del vecchio grigio, ho capito che ormai eravamo legati a lui quasi per la vita. Trascinati attraverso lo spazio come nei sogni e nelle tempeste, vedo Moussah che respinge molti ragazzi accorsi per acchiapparci. Lui è arrivato primo e ha diritto di prelazione su di noi. Dopo in corriera si offende che ho già dimenticato il suo nome. Io tento di impietosirlo spiegando che il ronzio alle orecchie va avanti sempre e mi fa perdere molti suoni, ma niente da fare. I bagagli potevo benissimo ritirarli anch’io, nessuna formalità per il ritiro, a parte il fatto che tutti si facevano avanti a gomitate per acchiappare enormi cartoni o enormi valige, oppure sacchi di riso o tubature imballate o gomme di ricambio e uno persino una cassa con tre galline vive che s’era portato in aereo da Parigi.
Naturalmente tutti parlano una lingua che non capisco, ma tanto qui non capisco quasi niente, e non so neanche cosa sono venuto a fare in Africa. Nel tragitto verso Bamako ho visto soltanto la terra rossa alla luce dei fanali, le strade piene di buche come se avessero bombardato. La piccola corriera aveva dei traballamenti da aereo in un vuoto d’aria. Poi la sfilata di casettine, per lo più baracche, oppure tettoie di paglia, porte di negozietti chiusi, e sopra le porte nel buio quei piccoli tubi bianchi al neon, come quelli usati da noi nel dopoguerra. Ogni casetta o baracca con l’aria di un’anima persa nella savana, ognuna col suo lumicino da fiaba, tubo al neon di luce smorta e polverosa. Per il resto ero frastonato da Moussah che ogni due minuti mi chiedeva se sto bene, io dicevo di sì sempre meno convinto. Cercavo di spiegargli che avevamo bisogno d’un albergo, ma lui continuava a far domande sull’Italia, voleva sapere se conosciamo un certo Armando di professione sarto. Solo dopo m’è venuto in mente che parlava del famoso couturier Armani.
Avventure in Africa
Per non considerarmi in vacanza devo scrivere ogni giorno come se fossi a casa, dunque lavorando come al solito, ma temporaneamente dislocato in un campo di concentramento per turisti.
Siamo nell’albergo intitolato hôtel de l’Amitié e mi chiedo di che razza d’amitié si tratta. I turisti qui sequestrati si capisce al volo che non hanno nessuna voglia di parlarsi e neanche di vedersi l’un con l’altro. In ascensore non sanno dove mettere gli occhi, fare amicizie sembra proibito. Questo albergo deve essere stato costruito nel periodo di regime socialista del Mali, e Jean dice che somiglia a molti palazzoni che si vedono a Mosca. Col suo aspetto da gigantesco alverare sa indubbiamente di sovietico, come altre cose che abbiamo visto in giro a cominciare dalla polizia. Secondo Jean sanno di sovietico anche le prostitute acquattate nell’ombra del bar, che hanno lo stesso atteggiamento delle prostitute nei vecchi alberghi di stato in Russia... Ma più di tutto ci prende alla sprovvista il fatto d’essere bianchi. Perché siamo qui a rappresentare non quello che siamo o crediamo d’essere, ma quello che dovremmo essere in quanto bianchi (ricchi, potenti, moderni, compratori di tutto). E portiamo in giro questa rappresentazione come uno scafandro, ognuno nel suo scafandro che lo isola dal mondo esterno. A Jean è venuta quasi una fissazione, e appena vede dei turisti comincia a ripetermi una parola che s’è inventata: “Guarda i pingoni bianchi, noi siamo così”. Ha anche scoperto che la regola dei pingoni è far finta di non vedersi quando si incrociano per strada, precisamente come fanno i clienti nell’hôtel de l’Amitié.
Avventure in Africa
Siamo nell’albergo intitolato hôtel de l’Amitié e mi chiedo di che razza d’amitié si tratta. I turisti qui sequestrati si capisce al volo che non hanno nessuna voglia di parlarsi e neanche di vedersi l’un con l’altro. In ascensore non sanno dove mettere gli occhi, fare amicizie sembra proibito. Questo albergo deve essere stato costruito nel periodo di regime socialista del Mali, e Jean dice che somiglia a molti palazzoni che si vedono a Mosca. Col suo aspetto da gigantesco alverare sa indubbiamente di sovietico, come altre cose che abbiamo visto in giro a cominciare dalla polizia. Secondo Jean sanno di sovietico anche le prostitute acquattate nell’ombra del bar, che hanno lo stesso atteggiamento delle prostitute nei vecchi alberghi di stato in Russia... Ma più di tutto ci prende alla sprovvista il fatto d’essere bianchi. Perché siamo qui a rappresentare non quello che siamo o crediamo d’essere, ma quello che dovremmo essere in quanto bianchi (ricchi, potenti, moderni, compratori di tutto). E portiamo in giro questa rappresentazione come uno scafandro, ognuno nel suo scafandro che lo isola dal mondo esterno. A Jean è venuta quasi una fissazione, e appena vede dei turisti comincia a ripetermi una parola che s’è inventata: “Guarda i pingoni bianchi, noi siamo così”. Ha anche scoperto che la regola dei pingoni è far finta di non vedersi quando si incrociano per strada, precisamente come fanno i clienti nell’hôtel de l’Amitié.
Avventure in Africa
Persino il sogno che descrivo a mia moglie mentre facciamo colazione è soltanto una prima bozza.
Penso come un genio, scrivo come un autore eminente e parlo come un bambino. Dall’inizio alla fine della mia carriera accademica negli Stati Uniti, da sparuto incaricato a professore di ruolo, non ho mai trasmesso al mio uditorio un solo briciolo di sapere che non fosse stato preparato e dattiloscritto in anticipo e che non fosse sotto i miei occhi sul leggio ben illuminato. Durante le telefonate interurbane i miei ehm-ehm e i miei mah-mah inducono gli interlocutori a passare dalla madrelingua inglese a un patetico francese. Ai ricevimenti, se cerco di intrattenere qualcuno con una storiella, devo ritornare su una buona metà delle mie frasi per integrazioni e cancellature orali. Persino il sogno che descrivo a mia moglie mentre facciamo colazione è soltanto una prima bozza.
Stando così le cose, nessuno dovrebbe chiedermi un’intervista se per «intervista» s’intende una chiacchierata fra due normali esseri umani.
Intransigenze
Penso come un genio, scrivo come un autore eminente e parlo come un bambino. Dall’inizio alla fine della mia carriera accademica negli Stati Uniti, da sparuto incaricato a professore di ruolo, non ho mai trasmesso al mio uditorio un solo briciolo di sapere che non fosse stato preparato e dattiloscritto in anticipo e che non fosse sotto i miei occhi sul leggio ben illuminato. Durante le telefonate interurbane i miei ehm-ehm e i miei mah-mah inducono gli interlocutori a passare dalla madrelingua inglese a un patetico francese. Ai ricevimenti, se cerco di intrattenere qualcuno con una storiella, devo ritornare su una buona metà delle mie frasi per integrazioni e cancellature orali. Persino il sogno che descrivo a mia moglie mentre facciamo colazione è soltanto una prima bozza.
Stando così le cose, nessuno dovrebbe chiedermi un’intervista se per «intervista» s’intende una chiacchierata fra due normali esseri umani.
Intransigenze
Dostoevski, che si occupava di temi accettati dalla maggior parte dei lettori come universali, per la loro portata e il loro significato, è ritenuto uno dei massimi scrittori del mondo. Lei però l’ha definito un mediocre autore che vuole far colpo, maldestro e volgare. Perché?
Chi non è russo non capisce due cose: che non tutti i russi amano Dostoevski quanto lo amano gli americani; e che la maggior parte dei russi che amano Dostoevski venerano in lui il mistico, non già l’artista. Era un profeta, un giornalista dalla lingua sciolta e un teatrante da strapazzo. Ammetto che alcune sue scene, alcune delle sue terribili, farsesche baruffe, sono divertentissime. Ma i suoi assassini dal cuore tenero e le sue prostitute dalla grande anima non si possono sopportare, nemmeno per un istante - il sottoscritto, in ogni caso, non li sopporta.
E' vero che ha definito Hemingway e Conrad « autori di libri per ragazzi » ?
È esattamente ciò che sono. Hemingway è certo il migliore dei due; se non altro ha una voce originale e il merito di avere scritto quel racconto delizioso, di alta qualità artistica, che è Gli uccisori. E la descri“zione del pesce iridescente e della ritmica emissione di urina nella sua celebre storia di pesca è splendida. Di Conrad, invece, non posso accettare lo stile da nego-zietto di souvenir, con le navi in bottiglia e le collane di conchiglie dei cliché romanticheggiami. In nessuno di questi due scrittori riesco a trovare qualcosa che mi piacerebbe avere scritto. Quanto a mentalità ed emozioni, sono irrimediabilmente infantili, e lo stesso si può dire di altri autori molto amati, beniamini della sala professori, conforto e sostegno degli studenti dei corsi di specializzazione, come... ma alcuni sono ancora vivi, e mi ripugna l’idea di ferire certi bravi vecchi mentre ci sono ancora dei morti da seppellire.
E che cosa leggeva, lei, da ragazzo?
Tra i dieci e i quindici anni, a San Pietroburgo, devo aver letto più narrativa e poesia - in inglese, russo e francese — che in qualsiasi altro lustro della mia vita. Mi entusiasmavano soprattutto le opere di Wells, Poe, Browning, Keats, Flaubert, Verlaine, Rimbaud, Cechov, Tolstoj e Aleksandr Blok. In un altro registro, i miei eroi erano la Primula Rossa, Phileas Fogg e Sherlock Holmes. Ero, in altre parole, il rampollo trilingue, perfettamente normale, di una famiglia con una vasta biblioteca. In un periodo successivo, nell’Europa occidentale, tra i venti e i quarant’anni, i miei autori prediletti erano Housman, Rupert Brooke, Norman Douglas, Bergson, Joyce, Proust e Pushkin. Tra questi, parecchi — Poe, Jules Verne, Emmuska Orczy, Conan Doyle e Rupert Brooke - hanno perso a poco a poco la capacità di ammaliarmi ed eccitarmi. Gli altri resistono intatti, e ormai, per quanto mi riguarda, è probabile che siano immuni da cambiamenti. Negli anni Venti e Trenta non ho mai subito, come invece è successo a tanti miei coetanei, le radiazioni della poesia di Eliot, non certo di prim’ordine, o di quella di Pound, sicuramente di second’ordine. Li ho letti a stagione inoltrata, intorno al 1945, nella stanza degli ospiti di un amico americano, e non solo mi hanno lasciato del tutto indifferente, ma non ho capito perché si debba perdere tempo con loro. Immagino però che Eliot e Pound conservino un certo valore sentimentale per i lettori che li hanno scoperti più precocemente di me.
E ora che cosa legge?
Di solito leggo parecchi libri per volta - libri vecchi, libri nuovi, narrativa, saggistica, poesia, di tutto - e quando sul comodino la pila di una dozzina di volumi si è ridotta a due o tre, il che avviene in genere in capo a una settimana, ne metto insieme un’altra. Ci sono alcune sottospecie di narrativa che non tocco mai: i gialli, per esempio, che mi ripugnano, e i romanzi storici. Detesto anche i cosiddetti romanzi « forti », pieni di trite oscenità e di dialoghi torrentizi; quando un editore speranzoso mi manda un nuovo romanzo - « sperando che il libro piaccia a me quanto è piaciuto a lui » -, controllo prima di tutto quanti dialoghi ci sono, e se vien fuori che sono troppi o troppo lunghi, chiudo il libro con un botto e lo bandisco dal mio letto.
C’è qualche autore contemporaneo che le piace leggere?
Certo, ho i miei beniamini: Robbe-Grillet e Borges, per esempio. Con quanta libertà e gratitudine si respira nei loro meravigliosi labirinti! Amo la loro lucidità di pensiero, la purezza e la poesia, il miraggio nello specchio.
Secondo molti critici, credo, questa descrizione può valere benissimo anche per la sua prosa. Fino a che punto pensa che prosa e poesia s’intreccino come forme d’arte?
Con la differenza che io ho cominciato prima: questa è la risposta alla prima parte della sua osservazione. Quanto alla seconda: be’, la poesia, naturalmente, abbraccia tutta la scrittura creativa; non sono mai riuscito a vedere una differenza di genere tra poesia e prosa artistica. Anzi, sarei incline a definire una buona poesia —corta o lunga, non ha importanza - come un concentrato di buona prosa, con o senza l’aggiunta di ritmi e rime ricorrenti. Lo strumento magico della prosodia può migliorare quella che chiamiamo prosa facendone sprigionare tutto il significato, ma anche nella prosa pura e semplice vi sono certi schemi ritmici, c’è la musica di un fraseggio preciso, la scansione del pensiero resa da peculiarità ricorrenti dell’idioma e dell’intonazione. Come nelle moderne classificazioni scientifiche, nel nostro concetto di poesia e di prosa c’è oggi molta sovrapposizione. Il ponte di bambù gettato fra l’una e l’altra è la metafora.
Intransigenze
Chi non è russo non capisce due cose: che non tutti i russi amano Dostoevski quanto lo amano gli americani; e che la maggior parte dei russi che amano Dostoevski venerano in lui il mistico, non già l’artista. Era un profeta, un giornalista dalla lingua sciolta e un teatrante da strapazzo. Ammetto che alcune sue scene, alcune delle sue terribili, farsesche baruffe, sono divertentissime. Ma i suoi assassini dal cuore tenero e le sue prostitute dalla grande anima non si possono sopportare, nemmeno per un istante - il sottoscritto, in ogni caso, non li sopporta.
E' vero che ha definito Hemingway e Conrad « autori di libri per ragazzi » ?
È esattamente ciò che sono. Hemingway è certo il migliore dei due; se non altro ha una voce originale e il merito di avere scritto quel racconto delizioso, di alta qualità artistica, che è Gli uccisori. E la descri“zione del pesce iridescente e della ritmica emissione di urina nella sua celebre storia di pesca è splendida. Di Conrad, invece, non posso accettare lo stile da nego-zietto di souvenir, con le navi in bottiglia e le collane di conchiglie dei cliché romanticheggiami. In nessuno di questi due scrittori riesco a trovare qualcosa che mi piacerebbe avere scritto. Quanto a mentalità ed emozioni, sono irrimediabilmente infantili, e lo stesso si può dire di altri autori molto amati, beniamini della sala professori, conforto e sostegno degli studenti dei corsi di specializzazione, come... ma alcuni sono ancora vivi, e mi ripugna l’idea di ferire certi bravi vecchi mentre ci sono ancora dei morti da seppellire.
E che cosa leggeva, lei, da ragazzo?
Tra i dieci e i quindici anni, a San Pietroburgo, devo aver letto più narrativa e poesia - in inglese, russo e francese — che in qualsiasi altro lustro della mia vita. Mi entusiasmavano soprattutto le opere di Wells, Poe, Browning, Keats, Flaubert, Verlaine, Rimbaud, Cechov, Tolstoj e Aleksandr Blok. In un altro registro, i miei eroi erano la Primula Rossa, Phileas Fogg e Sherlock Holmes. Ero, in altre parole, il rampollo trilingue, perfettamente normale, di una famiglia con una vasta biblioteca. In un periodo successivo, nell’Europa occidentale, tra i venti e i quarant’anni, i miei autori prediletti erano Housman, Rupert Brooke, Norman Douglas, Bergson, Joyce, Proust e Pushkin. Tra questi, parecchi — Poe, Jules Verne, Emmuska Orczy, Conan Doyle e Rupert Brooke - hanno perso a poco a poco la capacità di ammaliarmi ed eccitarmi. Gli altri resistono intatti, e ormai, per quanto mi riguarda, è probabile che siano immuni da cambiamenti. Negli anni Venti e Trenta non ho mai subito, come invece è successo a tanti miei coetanei, le radiazioni della poesia di Eliot, non certo di prim’ordine, o di quella di Pound, sicuramente di second’ordine. Li ho letti a stagione inoltrata, intorno al 1945, nella stanza degli ospiti di un amico americano, e non solo mi hanno lasciato del tutto indifferente, ma non ho capito perché si debba perdere tempo con loro. Immagino però che Eliot e Pound conservino un certo valore sentimentale per i lettori che li hanno scoperti più precocemente di me.
E ora che cosa legge?
Di solito leggo parecchi libri per volta - libri vecchi, libri nuovi, narrativa, saggistica, poesia, di tutto - e quando sul comodino la pila di una dozzina di volumi si è ridotta a due o tre, il che avviene in genere in capo a una settimana, ne metto insieme un’altra. Ci sono alcune sottospecie di narrativa che non tocco mai: i gialli, per esempio, che mi ripugnano, e i romanzi storici. Detesto anche i cosiddetti romanzi « forti », pieni di trite oscenità e di dialoghi torrentizi; quando un editore speranzoso mi manda un nuovo romanzo - « sperando che il libro piaccia a me quanto è piaciuto a lui » -, controllo prima di tutto quanti dialoghi ci sono, e se vien fuori che sono troppi o troppo lunghi, chiudo il libro con un botto e lo bandisco dal mio letto.
C’è qualche autore contemporaneo che le piace leggere?
Certo, ho i miei beniamini: Robbe-Grillet e Borges, per esempio. Con quanta libertà e gratitudine si respira nei loro meravigliosi labirinti! Amo la loro lucidità di pensiero, la purezza e la poesia, il miraggio nello specchio.
Secondo molti critici, credo, questa descrizione può valere benissimo anche per la sua prosa. Fino a che punto pensa che prosa e poesia s’intreccino come forme d’arte?
Con la differenza che io ho cominciato prima: questa è la risposta alla prima parte della sua osservazione. Quanto alla seconda: be’, la poesia, naturalmente, abbraccia tutta la scrittura creativa; non sono mai riuscito a vedere una differenza di genere tra poesia e prosa artistica. Anzi, sarei incline a definire una buona poesia —corta o lunga, non ha importanza - come un concentrato di buona prosa, con o senza l’aggiunta di ritmi e rime ricorrenti. Lo strumento magico della prosodia può migliorare quella che chiamiamo prosa facendone sprigionare tutto il significato, ma anche nella prosa pura e semplice vi sono certi schemi ritmici, c’è la musica di un fraseggio preciso, la scansione del pensiero resa da peculiarità ricorrenti dell’idioma e dell’intonazione. Come nelle moderne classificazioni scientifiche, nel nostro concetto di poesia e di prosa c’è oggi molta sovrapposizione. Il ponte di bambù gettato fra l’una e l’altra è la metafora.
Intransigenze
Centinaia, letteralmente centinaia
Be’, quando penso ai critici in generale, divido la famiglia in tre sottofamiglie. In primo luogo, i recensori di professione, quasi sempre imbrattacarte o zappaterra, che riempiono puntualmente lo spazio loro assegnato nei cimiteri dei giornali della domenica. In secondo luogo, i critici più ambiziosi, che ad anni alterni raccolgono i loro articoli in volumi dai sapienti titoli allusivi: La terra inesplorata, o roba del genere. E in terzo luogo, i miei colleghi scrittori, i quali recensiscono un libro che amano o detestano. Non poche brillanti fascette e fosche inimicizie sono nate in questo modo.
Quando uno scrittore di cui ammiro l’opera loda la mia, non posso non provare, insieme a una piccola onda di calore quasi umano, un senso di armonia e di logica rispettata. Ma ho anche la stupida sensazione che molto presto, se non faccio subito qualcosa, quel tale o quella tale si raffredderà e si defilerà alla chetichella; ma io non so che fare, e non faccio mai niente, ed ecco che la mattina dopo gelide nuvole nascondono le montagne piene di luce. In tutti gli altri casi, devo confessarlo, sbadiglio e dimentico. Certo, ogni autore che si rispetti ha la sua bella corte di buffoni e criticonzoli - splendida parola: criticonzoli, o criticastri —i quali, più che demolire lui, si demoliscono a vicenda con le loro pagliacciate.
Come se non bastasse, le mie varie antipatie, che di tanto in tanto mi piace manifestare, sembrano fatte apposta per irritare la gente. Si dà il caso che io giudichi effimere e di second’ordine le opere di parecchi scrittori gonfiati - come Camus, Lorca, Kazantzakis, D.H. Lawrence, Thomas Mann, Thomas Wolfe e centinaia, letteralmente centinaia, di altri « grandi » di second’ordine. Ed è ovvio che per questo motivo sono automaticamente detestato dai loro seguaci, dai seguaci del kitsch, dai seguaci delle mode e dai robot di ogni genere. Nell'insieme, per quel che riguarda la mia narrativa, resto sovranamente impassibile di fronte alle critiche sfavorevoli. E invece mi piace passare alle rappresaglie se qualche tronfio somaro trova da ridire sulle mie traduzioni e divulga una farsesca ignoranza della lingua e della letteratura russe.
Intransigenze
Be’, quando penso ai critici in generale, divido la famiglia in tre sottofamiglie. In primo luogo, i recensori di professione, quasi sempre imbrattacarte o zappaterra, che riempiono puntualmente lo spazio loro assegnato nei cimiteri dei giornali della domenica. In secondo luogo, i critici più ambiziosi, che ad anni alterni raccolgono i loro articoli in volumi dai sapienti titoli allusivi: La terra inesplorata, o roba del genere. E in terzo luogo, i miei colleghi scrittori, i quali recensiscono un libro che amano o detestano. Non poche brillanti fascette e fosche inimicizie sono nate in questo modo.
Quando uno scrittore di cui ammiro l’opera loda la mia, non posso non provare, insieme a una piccola onda di calore quasi umano, un senso di armonia e di logica rispettata. Ma ho anche la stupida sensazione che molto presto, se non faccio subito qualcosa, quel tale o quella tale si raffredderà e si defilerà alla chetichella; ma io non so che fare, e non faccio mai niente, ed ecco che la mattina dopo gelide nuvole nascondono le montagne piene di luce. In tutti gli altri casi, devo confessarlo, sbadiglio e dimentico. Certo, ogni autore che si rispetti ha la sua bella corte di buffoni e criticonzoli - splendida parola: criticonzoli, o criticastri —i quali, più che demolire lui, si demoliscono a vicenda con le loro pagliacciate.
Come se non bastasse, le mie varie antipatie, che di tanto in tanto mi piace manifestare, sembrano fatte apposta per irritare la gente. Si dà il caso che io giudichi effimere e di second’ordine le opere di parecchi scrittori gonfiati - come Camus, Lorca, Kazantzakis, D.H. Lawrence, Thomas Mann, Thomas Wolfe e centinaia, letteralmente centinaia, di altri « grandi » di second’ordine. Ed è ovvio che per questo motivo sono automaticamente detestato dai loro seguaci, dai seguaci del kitsch, dai seguaci delle mode e dai robot di ogni genere. Nell'insieme, per quel che riguarda la mia narrativa, resto sovranamente impassibile di fronte alle critiche sfavorevoli. E invece mi piace passare alle rappresaglie se qualche tronfio somaro trova da ridire sulle mie traduzioni e divulga una farsesca ignoranza della lingua e della letteratura russe.
Intransigenze
Ha un suo metodo nell’insegnamento della letteratura?
Posso farle qualche esempio. Quando studiavano il famoso racconto di Kafka, i miei allievi dovevano sapere esattamente in “quale tipo d’insetto si trasforma Gregor (è un tondeggiante scarabeo stercorario, non il piatto scarafaggio ai certi traduttori disinvolti) e dovevano essere in grado di descrivere esattamente la distribuzione delle stanze, con la posizione delle porte e dei mobili, nell’appartamento della famiglia Samsa. Per l'Ulisse dovevano conoscere la pianta di Dublino. Sono convinto che si debba insistere sul particolare specifico; le idee generali sanno badare a se stesse. L’Ulisse, naturalmente, è un’opera d’arte divina e continuerà a vivere a dispetto delle nullità accademiche che lo trasformano in una congerie di simboli o di miti greci. Una volta diedi un votaccio a uno studente solo perché aveva appioppato ai capitoli del libro i titoli presi in prestito da Omero senza neppure accorgersi degli andirivieni dell’uomo con l’impermeabile marrone. Non sapeva neppure chi fosse l’uomo con l’impermeabile marrone. Oh, sì, ben venga chi mi paragona a Joyce, ma il mio inglese è un tennis da strapazzo rispetto a quello di Joyce, che è un gioco da campione.
Come mai è venuto a vivere in Svizzera?
A mano a mano che invecchio e ingrasso, faccio sempre più fatica ad alzarmi da questa o quella comoda poltrona o sedia a sdraio in cui mi sono lasciato sprofondare esalando contentezza. Ormai, andare da Montreux a Losanna mi riesce difficile quanto un viaggio a Parigi, Londra o New York. Invece sono pronto a farmi quindici o venti chilometri al giorno, su e giù per i sentieri di montagna, in cerca di farfalle, come faccio ogni estate. Uno dei motivi per cui abito a Montreux è che la vista dalla mia poltrona ha un effetto meravigliosamente sedativo o eccitante, secondo il mio umore o l’umore del lago. Mi affretto ad aggiungere che non soltanto non sono un evasore fiscale, ma devo anche sborsare un bella sommetta all’erario svizzero in aggiunta alla mole delle tasse americane, così imponente che quasi mi priva di quella splendida vista. Sento una grande nostalgia per l’America, e non appena avrò raccolto l’energia necessaria ci tornerò per sempre.
Dov’è la poltrona?
La poltrona è nell’altra stanza, nel mio studio. Ma era una metafora: la poltrona è l’intero albergo, il giardino, tutto.
Dove andrebbe a vivere in America?
Credo che mi piacerebbe vivere in California, o a New York, o a Cambridge, nel Massachusetts. O in una combinazione di questi tre posti.
Spesso, per la padronanza dell’inglese, la paragonano a Joseph Conrad.
Be’, mettiamola così. Da ragazzo ero un lettore vorace, come pare siano tutti gli scrittori da piccoli, e fra gli otto e i quattordici anni andavo pazzo per i libri romantici - romantici in senso lato - di gente come Conan Doyle, Kipling, Joseph Conrad, Chesterton, Oscar Wilde e “altri che sono essenzialmente scrittori per giovanissimi. Ma come ho ben detto da qualche parte, sono diverso da Joseph Conradicalmente. Innanzi tutto, Conrad non ha mai scritto nella sua madrelingua prima di diventare uno scrittore inglese; e, in secondo luogo, oggi non sopporto più i suoi forbiti cliché e i suoi conflitti primitivi. Una volta scrisse che preferiva la traduzione di Anna Karenin di Mrs. Garnett all’originale! Sono cose che fan sognare — « ça fait rèver », come usava dire Flaubert di fronte a qualche abissale stupidità. Fin dai giorni in cui certe formidabili mediocrità come Galsworthy, Dreiser, una persona chiamata Tagore, un’altra chiamata Maksim Gorki, una terza chiamata Romain Rolland, passavano comunemente per geni, mi hanno sempre sconcertato e divertito le nozioni prefabbricate che circolano intorno ai « grandi libri ». Per esempio, che l’asinina Morte a Venezia di Mann o il melodrammatico e ignobilmente scritto Zhivago di Pasternak o le pannocchiesche cronache di Faulkner si possano giudicare « capolavori » - o almeno « grandi libri », per usare la formula giornalistica - è per me un’assurda illusione, come quando una persona ipnotizzata fa all’amore con una sedia. I miei massimi capolavori della narrativa del ventesimo secolo sono, nell’ordine, Ulisse di Joyce, La metamorfosi di Kafka, Pietroburgo di Bely e la prima metà della fiaba di Proust, Alla ricerca del tempo perduto.
E la letteratura americana! Vedo che non ci sono capolavori americani nella sua lista. Che cosa pensa della letteratura americana del dopoguerra?
Be’, è raro che in una generazione esistano simultaneamente più di due o tre scrittori davvero di prim’ordine. Penso che Salinger e Updike siano di gran lunga gli artisti migliori degli ultimi anni. Il bestseller fasullo, tutto sesso, il romanzo violento e volgare, l’esposizione romanzata di problemi sociali o politici e, in generale, i romanzi in cui prevalgono su tutto il resto i dialoghi o i commenti sociologici — questa roba è rigorosamente bandita dal mio comodino. E la popolare miscela di pornografia e frottole ideologiche è qualcosa che mi fa semplicemente vomitare.
Che cosa pensa della letteratura russa del dopoguerra?
La letteratura sovietica... Be’, subito dopo la rivoluzione bolscevica, negli anni Venti e all’inizio dei Trenta, si riusciva ancora a distinguere in mezzo alle spaventose insulsaggini della propaganda sovietica la voce agonizzante di una cultura anteriore. La mentalità primitiva e banale di una politica imposta — di qualsiasi politica — può solo produrre arte primitiva e banale. Ciò vale in particolare per la cosiddetta letteratura del « realismo socialista » e « proletaria » patrocinata dallo Stato di polizia sovietico. I suoi babbuini in stivaloni hanno sterminato a poco a poco gli autori veramente dotati, l’individuo eccezionale, il fragile genio. Uno dei casi più tristi è forse quello di Osip Mandelshtam — un poeta meraviglioso, il più grande tra quelli che in Russia hanno cercato di sopravvivere sotto i soviet “-, perseguitato da un’amministrazione brutale e imbecille, e infine mandato a morire in uno sperduto campo di concentramento.
Le poesie che continuò eroicamente a comporre fino a quando la pazzia oscurò il suo limpido genio sono esempi ammirevoli di quello che può una mente umana, in profondità e in altezza. La loro lettura accresce il salutare disprezzo per la ferocia sovietica.
I tiranni e i torturatori non riusciranno mai a nascondere i loro comici passi falsi dietro le loro cosmiche acrobazie. La risata sprezzante è un’ottima cosa, ma non basta per scaricare la coscienza. E quando leggo le poesie di Mandelshtam, composte sotto il maledetto regime di quelle bestie, provo una specie di vergogna impotente, io che sono così libero di vivere e pensare e scrivere e parlare nella parte libera del mondo. — Sono gii unici momenti in cui la libertà ha un sapore amaro.
Intransigenze
Posso farle qualche esempio. Quando studiavano il famoso racconto di Kafka, i miei allievi dovevano sapere esattamente in “quale tipo d’insetto si trasforma Gregor (è un tondeggiante scarabeo stercorario, non il piatto scarafaggio ai certi traduttori disinvolti) e dovevano essere in grado di descrivere esattamente la distribuzione delle stanze, con la posizione delle porte e dei mobili, nell’appartamento della famiglia Samsa. Per l'Ulisse dovevano conoscere la pianta di Dublino. Sono convinto che si debba insistere sul particolare specifico; le idee generali sanno badare a se stesse. L’Ulisse, naturalmente, è un’opera d’arte divina e continuerà a vivere a dispetto delle nullità accademiche che lo trasformano in una congerie di simboli o di miti greci. Una volta diedi un votaccio a uno studente solo perché aveva appioppato ai capitoli del libro i titoli presi in prestito da Omero senza neppure accorgersi degli andirivieni dell’uomo con l’impermeabile marrone. Non sapeva neppure chi fosse l’uomo con l’impermeabile marrone. Oh, sì, ben venga chi mi paragona a Joyce, ma il mio inglese è un tennis da strapazzo rispetto a quello di Joyce, che è un gioco da campione.
Come mai è venuto a vivere in Svizzera?
A mano a mano che invecchio e ingrasso, faccio sempre più fatica ad alzarmi da questa o quella comoda poltrona o sedia a sdraio in cui mi sono lasciato sprofondare esalando contentezza. Ormai, andare da Montreux a Losanna mi riesce difficile quanto un viaggio a Parigi, Londra o New York. Invece sono pronto a farmi quindici o venti chilometri al giorno, su e giù per i sentieri di montagna, in cerca di farfalle, come faccio ogni estate. Uno dei motivi per cui abito a Montreux è che la vista dalla mia poltrona ha un effetto meravigliosamente sedativo o eccitante, secondo il mio umore o l’umore del lago. Mi affretto ad aggiungere che non soltanto non sono un evasore fiscale, ma devo anche sborsare un bella sommetta all’erario svizzero in aggiunta alla mole delle tasse americane, così imponente che quasi mi priva di quella splendida vista. Sento una grande nostalgia per l’America, e non appena avrò raccolto l’energia necessaria ci tornerò per sempre.
Dov’è la poltrona?
La poltrona è nell’altra stanza, nel mio studio. Ma era una metafora: la poltrona è l’intero albergo, il giardino, tutto.
Dove andrebbe a vivere in America?
Credo che mi piacerebbe vivere in California, o a New York, o a Cambridge, nel Massachusetts. O in una combinazione di questi tre posti.
Spesso, per la padronanza dell’inglese, la paragonano a Joseph Conrad.
Be’, mettiamola così. Da ragazzo ero un lettore vorace, come pare siano tutti gli scrittori da piccoli, e fra gli otto e i quattordici anni andavo pazzo per i libri romantici - romantici in senso lato - di gente come Conan Doyle, Kipling, Joseph Conrad, Chesterton, Oscar Wilde e “altri che sono essenzialmente scrittori per giovanissimi. Ma come ho ben detto da qualche parte, sono diverso da Joseph Conradicalmente. Innanzi tutto, Conrad non ha mai scritto nella sua madrelingua prima di diventare uno scrittore inglese; e, in secondo luogo, oggi non sopporto più i suoi forbiti cliché e i suoi conflitti primitivi. Una volta scrisse che preferiva la traduzione di Anna Karenin di Mrs. Garnett all’originale! Sono cose che fan sognare — « ça fait rèver », come usava dire Flaubert di fronte a qualche abissale stupidità. Fin dai giorni in cui certe formidabili mediocrità come Galsworthy, Dreiser, una persona chiamata Tagore, un’altra chiamata Maksim Gorki, una terza chiamata Romain Rolland, passavano comunemente per geni, mi hanno sempre sconcertato e divertito le nozioni prefabbricate che circolano intorno ai « grandi libri ». Per esempio, che l’asinina Morte a Venezia di Mann o il melodrammatico e ignobilmente scritto Zhivago di Pasternak o le pannocchiesche cronache di Faulkner si possano giudicare « capolavori » - o almeno « grandi libri », per usare la formula giornalistica - è per me un’assurda illusione, come quando una persona ipnotizzata fa all’amore con una sedia. I miei massimi capolavori della narrativa del ventesimo secolo sono, nell’ordine, Ulisse di Joyce, La metamorfosi di Kafka, Pietroburgo di Bely e la prima metà della fiaba di Proust, Alla ricerca del tempo perduto.
E la letteratura americana! Vedo che non ci sono capolavori americani nella sua lista. Che cosa pensa della letteratura americana del dopoguerra?
Be’, è raro che in una generazione esistano simultaneamente più di due o tre scrittori davvero di prim’ordine. Penso che Salinger e Updike siano di gran lunga gli artisti migliori degli ultimi anni. Il bestseller fasullo, tutto sesso, il romanzo violento e volgare, l’esposizione romanzata di problemi sociali o politici e, in generale, i romanzi in cui prevalgono su tutto il resto i dialoghi o i commenti sociologici — questa roba è rigorosamente bandita dal mio comodino. E la popolare miscela di pornografia e frottole ideologiche è qualcosa che mi fa semplicemente vomitare.
Che cosa pensa della letteratura russa del dopoguerra?
La letteratura sovietica... Be’, subito dopo la rivoluzione bolscevica, negli anni Venti e all’inizio dei Trenta, si riusciva ancora a distinguere in mezzo alle spaventose insulsaggini della propaganda sovietica la voce agonizzante di una cultura anteriore. La mentalità primitiva e banale di una politica imposta — di qualsiasi politica — può solo produrre arte primitiva e banale. Ciò vale in particolare per la cosiddetta letteratura del « realismo socialista » e « proletaria » patrocinata dallo Stato di polizia sovietico. I suoi babbuini in stivaloni hanno sterminato a poco a poco gli autori veramente dotati, l’individuo eccezionale, il fragile genio. Uno dei casi più tristi è forse quello di Osip Mandelshtam — un poeta meraviglioso, il più grande tra quelli che in Russia hanno cercato di sopravvivere sotto i soviet “-, perseguitato da un’amministrazione brutale e imbecille, e infine mandato a morire in uno sperduto campo di concentramento.
Le poesie che continuò eroicamente a comporre fino a quando la pazzia oscurò il suo limpido genio sono esempi ammirevoli di quello che può una mente umana, in profondità e in altezza. La loro lettura accresce il salutare disprezzo per la ferocia sovietica.
I tiranni e i torturatori non riusciranno mai a nascondere i loro comici passi falsi dietro le loro cosmiche acrobazie. La risata sprezzante è un’ottima cosa, ma non basta per scaricare la coscienza. E quando leggo le poesie di Mandelshtam, composte sotto il maledetto regime di quelle bestie, provo una specie di vergogna impotente, io che sono così libero di vivere e pensare e scrivere e parlare nella parte libera del mondo. — Sono gii unici momenti in cui la libertà ha un sapore amaro.
Intransigenze
Si diverte un mondo a sparare a tutto spiano ma alla fine mi sembra anche più onesto così: in letteratura o si ama o si bandisce dal comodino, inutile star tanto a girarci attorno (al comodino) :)
Non bisogna commiserarsi
Sul palcoscenico non ci si lascia dietro niente. Il palcoscenico se ne infischia di chi lo occupa, Giselle, Giselle Fayolle, Anne-Marie
Neanche una traccia di nessuno. Né l’odore. Né l’ombra
Ho avuto una vita felice, sa
Non avevo il fisico per il cinema
Ho fatto Clitennestra, signorina cara, a un’età in cui nella vita vera non ero ancora madre
Raymond Lice faceva Agamennone
Raymond Lice nei panni di Agamennone era un delirio, un controsenso totale, Raymond Lice che aveva perennemente addosso quel fetore di cipolla nei panni del re di Micene, gli dicevo puzzi di cipolla, lui diceva invece di criticare dammi una mentina, no, tu hai bisogno di ben altro che di una mentina Raymond è il tuo esofago. Si offendeva perché criticavo la sua digestione. Raymond aveva quarant’anni più di noi e la testa fissata direttamente sul busto. Io avevo un’acconciatura alla greca, a balze, con i nastri e in cima al capo una grossa torre ondulata. Al quarto atto, mentre mi gettavo ai suoi piedi, mi sfilavo alla chetichella uno spillone, le ciocche della parrucca mi cadevano sulle spalle, sul viso, lungo la schiena, in boccoli soprannaturali, io li scuotevo in tutti i sensi agitando la testa, facevo una voce affannosa ma ardente, Raymond faceva la sua voce cavernosa ed eravamo la beltà e il re dell’impero
A volte, sul palcoscenico, sono stata Anne-Marie la beltà
Sì, signorina
Sì, cara

Sul palcoscenico non ci si lascia dietro niente. Il palcoscenico se ne infischia di chi lo occupa, Giselle, Giselle Fayolle, Anne-Marie
Neanche una traccia di nessuno. Né l’odore. Né l’ombra
Ho avuto una vita felice, sa
Non avevo il fisico per il cinema
Ho fatto Clitennestra, signorina cara, a un’età in cui nella vita vera non ero ancora madre
Raymond Lice faceva Agamennone
Raymond Lice nei panni di Agamennone era un delirio, un controsenso totale, Raymond Lice che aveva perennemente addosso quel fetore di cipolla nei panni del re di Micene, gli dicevo puzzi di cipolla, lui diceva invece di criticare dammi una mentina, no, tu hai bisogno di ben altro che di una mentina Raymond è il tuo esofago. Si offendeva perché criticavo la sua digestione. Raymond aveva quarant’anni più di noi e la testa fissata direttamente sul busto. Io avevo un’acconciatura alla greca, a balze, con i nastri e in cima al capo una grossa torre ondulata. Al quarto atto, mentre mi gettavo ai suoi piedi, mi sfilavo alla chetichella uno spillone, le ciocche della parrucca mi cadevano sulle spalle, sul viso, lungo la schiena, in boccoli soprannaturali, io li scuotevo in tutti i sensi agitando la testa, facevo una voce affannosa ma ardente, Raymond faceva la sua voce cavernosa ed eravamo la beltà e il re dell’impero
A volte, sul palcoscenico, sono stata Anne-Marie la beltà
Sì, signorina
Sì, cara

Piatta è piatta. Su questo non c’è alcun dubbio. Si stende a perdita d’occhio interrotta solo da filari di pioppi e piccoli boschetti sopravvissuti alle trasformazioni agricole dell’ultimo secolo e mezzo. Se provi a camminare, la cosa migliore è seguire uno dei tanti canali che tracciano direttrici dentro il piatto senza fine. Non procedere lungo la strada, perché potrebbe essere pericoloso anche di giorno, sebbene raramente passi qualcuno, e quando sfreccia un’automobile lungo il rettifilo, è meglio scendere nel fossatello laterale e lasciarla passare, anche a costo di bagnarsi le scarpe, perché, salvo i mesi caldi, un po’ d’acqua reflua c’è sempre.
Il fatto è che non è bene stare sull’asfalto a fare da bersaglio. Dato che qui nessuno cammina lungo la strada, le vetture si lanciano ad alta velocità, una piccola ebbrezza da queste parti – tutti piloti in Emilia – e manco ti vedono. Tu sei un puntino all’orizzonte, un puntino che non si vede neppure, al massimo sei poco piú grande di un moscerino e quando t’inquadrano sul vetro del parabrezza, sono già oltre e probabilmente ti hanno urtato; se ti va bene, sbattuto giú nel canale. Dove è meglio, data la situazione, scendere da sé.

Il fatto è che non è bene stare sull’asfalto a fare da bersaglio. Dato che qui nessuno cammina lungo la strada, le vetture si lanciano ad alta velocità, una piccola ebbrezza da queste parti – tutti piloti in Emilia – e manco ti vedono. Tu sei un puntino all’orizzonte, un puntino che non si vede neppure, al massimo sei poco piú grande di un moscerino e quando t’inquadrano sul vetro del parabrezza, sono già oltre e probabilmente ti hanno urtato; se ti va bene, sbattuto giú nel canale. Dove è meglio, data la situazione, scendere da sé.

La forma della nostra pianura. Pensa te, andare in Africa per capire tutto.
I Romani si sa, sono stati dappertutto, e ancora si trovano loro tracce in luoghi remoti dove non si crede che siano stati, e invece sí. Hanno diviso il mondo che possedevano in quadrati e poi in rettangoli piú piccoli. Ebbene questo Falbe era un militare e aveva preso parte alle guerre napoleoniche, capitano di vascello, poi console generale della Danimarca a Tunisi, quindi in Grecia. Aveva smesso di navigare sulle navi del suo paese, era sceso a terra e si era messo a camminare. Aveva anche la passione per le medaglie, cosí che era finito, credo dopo tutto questo, ma non ne sono sicuro, a lavorare al Gabinetto numismatico di Rosenborg, Palazzo Reale, Copenaghen.
Nel ritratto che ho scovato ha l’aria di un ragazzo mal cresciuto con due occhi molto grandi e il visino piccolo, una capigliatura scomposta che gli cade a ciuffo sulla destra. Forse l’hanno ritratto al mattino presto, appena alzato, quando non si era sistemato con il pettine. Che sia un uomo di mare si capisce dalla miniatura opera di un tale Autissier, conservata al Museo navale della capitale danese, dove si scorge un vascello visto di poppa sulla destra e poi l’abito da ufficiale con le mostrine. Ebbene questo signore è colui che ha scoperto la storia della forma della nostra pianura. Immagino, per quanto non ne sia certo, che non sia mai venuto da queste parti e neppure che si sia fermato in una delle vecchie osterie di qui. Allora, nel 1833, ce n’erano.
Arrivando a Cartagine Falbe si era lamentato che nessuno avesse ancora disegnato una carta attendibile del luogo, cosí che dovette fare un rilevamento topografico delle rovine e della città di Cartagine. Poiché era un acquerellista, e neppure male, da come si può giudicare alla Biblioteca reale danese, si mise a dipingere quello che vedeva: le terme, la baia di Tunisi, la città. Sono opere di un certo gusto, con resti di muri, asini, case tradizionali. Insomma un uomo dai molti talenti quel marinaio d’acqua salata. Fece dei rilevamenti, ma con molta discrezione per non irritare le autorità locali, visto che era un militare, e poi un diplomatico; la gente era sospettosa a quelle latitudini, e non solo. Lui non mirava alle rovine, bensí alla metrica dello spazio, alla centuriazione.
Ecco di nuovo la parola. Centuriazione. Il Gran Danese ha scoperto, o meglio riscoperto, questo metodo di definizione del territorio. Prima di andare avanti, e arrivare alla lettera, voglio raccontare altre cose della storia di Falbe. La carta che realizzò era in scala 1:16 000. Fece il rilievo dei luoghi “– case di campagna di colleghi – e le misure usate erano in piedi francesi. Si concentrò sulla zona dell’antica Cartagine, la capitale mancata dell’antichità. Si è conservata la carta che realizzò. Gli arabi insediatisi avevano costruito le strade, i muri, le case e persino i giardini, seguendo le linee tracciate dai romani. Tutto secondo quei 708 metri di lato, tradotti in 2400 piedi: la centuria.
Non ti pare possibile che questo paesaggio qui davanti, fuori dal bar, lungo i campi, i canali e i fossati sia lo stesso di allora? Invece sí. Tutto segue quel reticolo steso secoli e secoli fa dai nostri predecessori. Predecessori? Ti sei mai chiesto da chi discendi tu? Liguri, Galli Boi, Etruschi, Latini, Umbri, Volsci, Piceni. Chi lo sa? Ci siamo cosí mescolati in questi due o tre millenni che dirlo è difficile, anche se c’è chi ha studiato i nostri DNA, andando tanto indietro da accertare quanto in noi, Homo sapiens sapiens, ci sia degli uomini e delle donne di Neanderthal. Ebbene, nonostante tutto questo rimescolamento di geni e popolazioni, predoni saraceni compresi, l’unica cosa rimasta visibile – perché il DNA chi lo vede, e poi i tratti somatici chi li sa piú leggere, scomparso Lombroso? – sono proprio le centurie romane.

I Romani si sa, sono stati dappertutto, e ancora si trovano loro tracce in luoghi remoti dove non si crede che siano stati, e invece sí. Hanno diviso il mondo che possedevano in quadrati e poi in rettangoli piú piccoli. Ebbene questo Falbe era un militare e aveva preso parte alle guerre napoleoniche, capitano di vascello, poi console generale della Danimarca a Tunisi, quindi in Grecia. Aveva smesso di navigare sulle navi del suo paese, era sceso a terra e si era messo a camminare. Aveva anche la passione per le medaglie, cosí che era finito, credo dopo tutto questo, ma non ne sono sicuro, a lavorare al Gabinetto numismatico di Rosenborg, Palazzo Reale, Copenaghen.
Nel ritratto che ho scovato ha l’aria di un ragazzo mal cresciuto con due occhi molto grandi e il visino piccolo, una capigliatura scomposta che gli cade a ciuffo sulla destra. Forse l’hanno ritratto al mattino presto, appena alzato, quando non si era sistemato con il pettine. Che sia un uomo di mare si capisce dalla miniatura opera di un tale Autissier, conservata al Museo navale della capitale danese, dove si scorge un vascello visto di poppa sulla destra e poi l’abito da ufficiale con le mostrine. Ebbene questo signore è colui che ha scoperto la storia della forma della nostra pianura. Immagino, per quanto non ne sia certo, che non sia mai venuto da queste parti e neppure che si sia fermato in una delle vecchie osterie di qui. Allora, nel 1833, ce n’erano.
Arrivando a Cartagine Falbe si era lamentato che nessuno avesse ancora disegnato una carta attendibile del luogo, cosí che dovette fare un rilevamento topografico delle rovine e della città di Cartagine. Poiché era un acquerellista, e neppure male, da come si può giudicare alla Biblioteca reale danese, si mise a dipingere quello che vedeva: le terme, la baia di Tunisi, la città. Sono opere di un certo gusto, con resti di muri, asini, case tradizionali. Insomma un uomo dai molti talenti quel marinaio d’acqua salata. Fece dei rilevamenti, ma con molta discrezione per non irritare le autorità locali, visto che era un militare, e poi un diplomatico; la gente era sospettosa a quelle latitudini, e non solo. Lui non mirava alle rovine, bensí alla metrica dello spazio, alla centuriazione.
Ecco di nuovo la parola. Centuriazione. Il Gran Danese ha scoperto, o meglio riscoperto, questo metodo di definizione del territorio. Prima di andare avanti, e arrivare alla lettera, voglio raccontare altre cose della storia di Falbe. La carta che realizzò era in scala 1:16 000. Fece il rilievo dei luoghi “– case di campagna di colleghi – e le misure usate erano in piedi francesi. Si concentrò sulla zona dell’antica Cartagine, la capitale mancata dell’antichità. Si è conservata la carta che realizzò. Gli arabi insediatisi avevano costruito le strade, i muri, le case e persino i giardini, seguendo le linee tracciate dai romani. Tutto secondo quei 708 metri di lato, tradotti in 2400 piedi: la centuria.
Non ti pare possibile che questo paesaggio qui davanti, fuori dal bar, lungo i campi, i canali e i fossati sia lo stesso di allora? Invece sí. Tutto segue quel reticolo steso secoli e secoli fa dai nostri predecessori. Predecessori? Ti sei mai chiesto da chi discendi tu? Liguri, Galli Boi, Etruschi, Latini, Umbri, Volsci, Piceni. Chi lo sa? Ci siamo cosí mescolati in questi due o tre millenni che dirlo è difficile, anche se c’è chi ha studiato i nostri DNA, andando tanto indietro da accertare quanto in noi, Homo sapiens sapiens, ci sia degli uomini e delle donne di Neanderthal. Ebbene, nonostante tutto questo rimescolamento di geni e popolazioni, predoni saraceni compresi, l’unica cosa rimasta visibile – perché il DNA chi lo vede, e poi i tratti somatici chi li sa piú leggere, scomparso Lombroso? – sono proprio le centurie romane.

It is spring, moonless night in the small town, starless and bible-black, the cobblestreets silent and the hunched, courters'-and-rabbits' wood limping invisible down to the sloeblack, slow, black, crowblack, fishingboatbobbing sea.

Iniziamo dall’inizio:
È primavera, sulla piccola città notte senza luna, senza stelle e nera come una Bibbia, silenziose le strade di ciottoli e il bosco gibboso degli amanti e dei conigli che arranca invisibile al mare nero; nero come susine di macchia, pigro, nero, nero come il corvo, ballonzolante di barche da pesca. Le case sono cieche come talpe (anche se le talpe ci vedono benissimo, stanotte, nei cunicoli delle vallette vellutate) o cieche come Capitan Gatto che se ne sta laggiú nel centro felpato della cittadina, accanto alla pompa dell’acqua e la torre dell’orologio, le botteghe a lutto e l’Istituto di Beneficenza in vesti vedovili. E tutti qui, nella città ammutolita e quieta, dormono, ora.
Sst… i bambini stanno dormendo e dormono i fattori, i negozianti e i pensionati, calzolaio, maestro di scuola, postino e oste, l’impresario delle pompe funebri e la prostituta, ubriacone, sarto, predicatore, agente di polizia, le pescatrici di vongole dai piedi palmati e le mogli tutte linde. Ragazze stanno mollemente distese a letto o scivolano nei loro sogni: anelli e corredi e lucciole per damigelle d’onore lungo le navate di un bosco dove risuona musica d’organo. I ragazzi sognano di gran peccati o l’impennarsi del bestiame della notte e la bandiera nera e il mare solcato dalle navi dei corsari. E le statue d’antracite dei cavalli dormono nei campi, e le mucche nelle stalle, e i cani nei cortili bagnati come il loro naso; e i gatti sonnecchiano negli angoli sghembi o balzano fuori furtivi, svelti e insinuanti come aghi, sull’unica nube dei tetti.
Si sente cadere la rugiada, e il respiro della città silenziosa.
Soltanto i vostri occhi sono un poco aperti, per vedere la città nera e ben ripiegata su se stessa, e pigra, nel sonno.
E voi soltanto riuscite a sentire l’invisibile cadere delle stelle, il moto prima dell’alba, oscuro piú che mai e scalfito da piccole gocce di rugiada, del nero mare, fitto di sogliole e limande, dove l’Arethusa, Curlew e Skylark, lo Zanzibar, Rhiannon, e il Rover, Cormorant e Star of Wales sghembi fendono le onde.
Ascoltate. Questa è la notte che avanza nelle strade, è il vento musicale salmastro e lento come una processione in Coronation Street e in Cockle Row, è l’erba che cresce sul colle di Llareggub, il cadere della rugiada, il cadere delle stelle, il sonno degli uccelli a Milk Wood.
Ascoltate. È notte nella gelida, tozza cappella echeggiante di canti in cuffietta e spilla e crespo nero, colletto a farfalla e stringhe a fiocco, tossendo come caprette, succhiando pasticche alla menta e a ogni alleluia sbattendo quaranta volte le palpebre; è notte nella birreria da quattro soldi, tranquilla come una tessera del domino; e nel solaio di Ocky il lattaio è, la notte, uguale a un topo con i guanti; e nella panetteria di Dai Bread si disperde in aria come nera farina. È notte in Donkey Street, e trotterella silenziosa con gli zoccoli ricoperti d’alghe sul selciato di ciottoli e conchiglie, oltre i vasi di felci dietro le tendine, il versetto della Bibbia e il ninnolo, l’armonium e l’armadio dei paramenti, gli acquerelli fatti in casa, il cagnolino di porcellana e il barattolo di latta rosa per il tè. È notte e sonnecchia come un asinello nei tranquilli cantucci dei lattanti.
Guardate. È notte e si muove come una biscia, muta e regale, tra i ciliegi di Coronation Street; attraversa il camposanto di Bethesda portata da venti inguantati, avvolti su se stessi e stillanti di rugiada; e barcollando ruzzola davanti all’Osteria dei Marinai.
Il tempo passa. Ascoltate. Il tempo passa.
Venite piú vicino adesso.
Soltanto voi potete sentire le case che dormono nelle strade nella notte bendata e salmastra, nera e profonda, silenziosa e pigra. Soltanto voi potete vedere, nelle camere cieche, le sottovesti e le sottane sulle sedie, le brocche e i catini, i bicchieri con le dentiere, il Non Devi alla parete, e i ritratti dei morti che vanno ingiallendo e che vegliano come gli uccellini meccanici dei fotografi. Soltanto voi potete sentire e vedere, dietro gli occhi dei dormienti, i moti e i paesi e i labirinti e i colori e gli sgomenti e gli arcobaleni e le melodie e i desideri e voli, cadute, disperazioni e i mari in tempesta dei loro sogni.
Ora da qui, dove siete ora, quei sogni potete sentirli.
Capitan Gatto, il capitano di mare cieco e a riposo, addormentato nella cuccetta di una cabina della Casa del Brigantino, la cabina migliore tutta incrostata di conchiglie e a forma di nave dentro una nave in bottiglia, sogna...

Iniziamo dall’inizio:
È primavera, sulla piccola città notte senza luna, senza stelle e nera come una Bibbia, silenziose le strade di ciottoli e il bosco gibboso degli amanti e dei conigli che arranca invisibile al mare nero; nero come susine di macchia, pigro, nero, nero come il corvo, ballonzolante di barche da pesca. Le case sono cieche come talpe (anche se le talpe ci vedono benissimo, stanotte, nei cunicoli delle vallette vellutate) o cieche come Capitan Gatto che se ne sta laggiú nel centro felpato della cittadina, accanto alla pompa dell’acqua e la torre dell’orologio, le botteghe a lutto e l’Istituto di Beneficenza in vesti vedovili. E tutti qui, nella città ammutolita e quieta, dormono, ora.
Sst… i bambini stanno dormendo e dormono i fattori, i negozianti e i pensionati, calzolaio, maestro di scuola, postino e oste, l’impresario delle pompe funebri e la prostituta, ubriacone, sarto, predicatore, agente di polizia, le pescatrici di vongole dai piedi palmati e le mogli tutte linde. Ragazze stanno mollemente distese a letto o scivolano nei loro sogni: anelli e corredi e lucciole per damigelle d’onore lungo le navate di un bosco dove risuona musica d’organo. I ragazzi sognano di gran peccati o l’impennarsi del bestiame della notte e la bandiera nera e il mare solcato dalle navi dei corsari. E le statue d’antracite dei cavalli dormono nei campi, e le mucche nelle stalle, e i cani nei cortili bagnati come il loro naso; e i gatti sonnecchiano negli angoli sghembi o balzano fuori furtivi, svelti e insinuanti come aghi, sull’unica nube dei tetti.
Si sente cadere la rugiada, e il respiro della città silenziosa.
Soltanto i vostri occhi sono un poco aperti, per vedere la città nera e ben ripiegata su se stessa, e pigra, nel sonno.
E voi soltanto riuscite a sentire l’invisibile cadere delle stelle, il moto prima dell’alba, oscuro piú che mai e scalfito da piccole gocce di rugiada, del nero mare, fitto di sogliole e limande, dove l’Arethusa, Curlew e Skylark, lo Zanzibar, Rhiannon, e il Rover, Cormorant e Star of Wales sghembi fendono le onde.
Ascoltate. Questa è la notte che avanza nelle strade, è il vento musicale salmastro e lento come una processione in Coronation Street e in Cockle Row, è l’erba che cresce sul colle di Llareggub, il cadere della rugiada, il cadere delle stelle, il sonno degli uccelli a Milk Wood.
Ascoltate. È notte nella gelida, tozza cappella echeggiante di canti in cuffietta e spilla e crespo nero, colletto a farfalla e stringhe a fiocco, tossendo come caprette, succhiando pasticche alla menta e a ogni alleluia sbattendo quaranta volte le palpebre; è notte nella birreria da quattro soldi, tranquilla come una tessera del domino; e nel solaio di Ocky il lattaio è, la notte, uguale a un topo con i guanti; e nella panetteria di Dai Bread si disperde in aria come nera farina. È notte in Donkey Street, e trotterella silenziosa con gli zoccoli ricoperti d’alghe sul selciato di ciottoli e conchiglie, oltre i vasi di felci dietro le tendine, il versetto della Bibbia e il ninnolo, l’armonium e l’armadio dei paramenti, gli acquerelli fatti in casa, il cagnolino di porcellana e il barattolo di latta rosa per il tè. È notte e sonnecchia come un asinello nei tranquilli cantucci dei lattanti.
Guardate. È notte e si muove come una biscia, muta e regale, tra i ciliegi di Coronation Street; attraversa il camposanto di Bethesda portata da venti inguantati, avvolti su se stessi e stillanti di rugiada; e barcollando ruzzola davanti all’Osteria dei Marinai.
Il tempo passa. Ascoltate. Il tempo passa.
Venite piú vicino adesso.
Soltanto voi potete sentire le case che dormono nelle strade nella notte bendata e salmastra, nera e profonda, silenziosa e pigra. Soltanto voi potete vedere, nelle camere cieche, le sottovesti e le sottane sulle sedie, le brocche e i catini, i bicchieri con le dentiere, il Non Devi alla parete, e i ritratti dei morti che vanno ingiallendo e che vegliano come gli uccellini meccanici dei fotografi. Soltanto voi potete sentire e vedere, dietro gli occhi dei dormienti, i moti e i paesi e i labirinti e i colori e gli sgomenti e gli arcobaleni e le melodie e i desideri e voli, cadute, disperazioni e i mari in tempesta dei loro sogni.
Ora da qui, dove siete ora, quei sogni potete sentirli.
Capitan Gatto, il capitano di mare cieco e a riposo, addormentato nella cuccetta di una cabina della Casa del Brigantino, la cabina migliore tutta incrostata di conchiglie e a forma di nave dentro una nave in bottiglia, sogna...
Un intero capitolo (non avrei saputo/potuto frammentarlo) dei Lavoratori del mare di Victor Hugo, abbastanza lungo ma, considerando che parla del tutto, non così tanto.
"SUB UMBRA”
A volte, di notte, Gilliat apriva gli occhi e guardava le tenebre.
Si sentiva stranamente commosso.
L’occhio aperto nel buio. Situazione lugubre; ansia.
La pressione dell’ombra esiste.
Un’indefinibile soffitto di tenebre, un’alta oscurità nella quale è impossibile penetrare; frammista a quell’oscurità, una non so che luce, vinta e cupa. Chiarore ridotto in polvere. È seme? È cenere? Milioni di fiaccole senza la minima illuminazione: un vasto fiammeggiare che non svela il suo segreto; un diffondersi di fuoco polverizzato che sembra un volo di scintille arrestato. Il disordine del turbine e l’immobilità del sepolcro; il problema che offre una soluzione da precipizio; l’enigma che mostra e nasconde il suo volto; l’infinito mascherato di nero: ecco la Notte. Tale sovrapposizione è pesante per l’uomo.
Quest’amalgama di tutti i misteri, dal cosmico al fatale, opprime il cervello umano.
La pressione delle tenebre agisce in senso inverso sulle diverse specie di anime. L’uomo, davanti alla notte, si riconosce incompleto. Vede il buio e sente l’infermità. Il cielo nero è l’uomo cieco. L’uomo, a faccia a faccia con la notte, si abbatte, si inginocchia, si prosterna, si distende bocconi, striscia verso un rifugio o si cerca delle ali. Quasi sempre egli vuol fuggire l’informe presenza dell’Ignoto. Si domanda che cosa sia, trema, si china, ignora e, talvolta anche, vuole andargli incontro.
Incontro dove?
Là!
Là? Che cos’è? E che cosa c’è?
Tale curiosità è evidentemente quella delle cose proibite, perché da questo lato tutti i ponti sono rotti intorno all’uomo. Manca l’arco dell’infinito. Ma ciò che è proibito attira, perché è abisso. Dove non va il piede, può giungere lo sguardo; dove lo sguardo si arresta, può proseguire lo spirito. Non c’è uomo che non tenti, per quanto debole e insufficiente sia. A seconda della sua natura, l’uomo è in cerca o in arresto davanti alla notte. Per alcuni è una compressione, per altri una dilatazione. Lo spettacolo è cupo. Vi si mischia l’indefinibile.
La notte è serena? È un fondo d’ombra. È tempestosa? È un fondo di fumo. L’illimitato si offre e si rifiuta nel tempo stesso, chiuso all’esperimento, aperto all’ipotesi. Innumerevoli punteggiature di luce rendono più nera l’oscurità senza fondo: gemme, scintillii di astri, presenze accertate nell’ignoto, spaventose sfide ad andare a toccar quelle luci. Sono segnali di creazione nell’assoluto; limiti di distanza là dove non ci sono più distanze; è una non so quale numerazione impossibile, e tuttavia reale, dei gradi delle profondità. Un punto microscopico che brilla, poi un altro, poi ancora un altro: è l’impercettibile, l’enorme. Quella luce è un focolare, quel focolare è una stella, quella stella è un sole, quel sole è un universo, quell’universo non è nulla.
Ogni numero è zero di fronte all’infinito.
Quegli universi, che non sono nulla, esistono. Nell’osservarli si sente la differenza che passa tra l’essere nulla e il non essere.
L’inaccessibile aggiunto all’impenetrabile, l’impenetrabile aggiunto all’inesplicabile; ecco che cos’è il cielo.
Da tale contemplazione deriva un fenomeno sublime: l’ingrandimento dell’anima per mezzo dello stupore.
Il terrore sacro è proprio dell’uomo. La bestia non conosce questo genere di paura. L’intelligenza ha, in tale augusta paura, la sua eclisse e la sua prova.
L’oscurità è una: da ciò l’errore. E, al tempo stesso, è complessa: di qui lo spavento. La sua unità fa massa sul nostro spirito e toglie il desiderio di resistere. La sua complessità fa sì che noi ci guardiamo d’intorno da tutti i lati e ci pare di dover temere bruschi assalti. Ci arrendiamo e ci guardiamo. Siamo in presenza di Tutto: da ciò la sottomissione; e di Molti: da ciò la diffidenza. L’unità dell’ombra contiene un multiplo. Multiplo misterioso, visibile nella materia, sensibile nel pensiero. Esso tace: motivo di più per stare in guardia.
La notte – chi scrive queste parole lo ha già detto altrove – è lo stato proprio e normale della creazione di cui facciamo parte. Il giorno, breve nella durata come nello spazio, non è che una misura stellare.
L’universale prodigio notturno non si compie senza attriti, e tutti gli attriti di una simile macchina sono delle contusioni per la vita. Ciò che noi chiamiamo Male sono appunto questi attriti della macchina. In quell’oscurità noi avvertiamo il Male come latente smentita all’ordine divino, bestemmia implicita del fatto ribelle all’ideale. Il Male complica di una indefinibile teratologia dalle mille teste l’immenso complesso cosmico. Il Male è presente ovunque per protestare. È uragano, e disturba la rotta di una nave; è caos, e intralcia la nascita di un mondo. Il Bene ha l’unità; il Male ha l’ubiquità. Il Male sconcerta la vita, che è una logica. Fa divorare la mosca dall’uccello e il pianeta dalla cometa. Il Male è una cancellatura fatta sulla creazione.
L’oscurità notturna è piena di una vertigine. Chi la approfondisce, si sommerge in essa e vi si dibatte. Nessuna fatica è paragonabile all’esame delle tenebre. È come lo studio di una cosa svanita.
Non c’è un posto definito sul quale appoggiare lo spirito. Punti di partenza privi di punti d’arrivo. L’incrociarsi delle soluzioni contradittorie, tutte le ramificazioni del dubbio che si offrono contemporaneamente, tutta la molteplicità dei fenomeni che si svolgono senza limiti per una indefinita generazione, tutte le leggi che si confondono l’una con l’altra, una promiscuità insondabile, la quale fa sì che la mineralizzazione vegeti, che la vegetazione viva, che il pensiero pesi, che l’amore risplenda e che la gravitazione ami; l’immensa fronte d’attacco di tutte le questioni che si sviluppano nell’oscurità illimitata; l’intravisto che abbozza l’ignorato; la simultaneità cosmica in piena apparizione, non per lo sguardo, ma per l’intelligenza, nel grande spazio indistinto; l’invisibile che diventa visione: ecco l’ombra. L’uomo è sotto di essa.
Non conosce i particolari; ma sopporta, in quantità proporzionata al suo spirito, il peso mostruoso dell’assieme. Tale ossessione spingeva i pastori della Caldea verso l’astronomia. Dai pori della creazione escono rivelazioni involontarie; si forma, in certo modo, un trasudamento di scienza e conquista l’ignorante. Ogni solitario, per effetto di tale penetrazione misteriosa, diviene spesso, senza rendersene conto, un filosofo; così, istintivamente.
L’oscurità è indivisibile. È abitata. Abitata senza spostamento da parte dell’Assoluto; abitata anche con spostamento. Qualche cosa si muove in essa. Una formazione sacra vi compie le sue fasi. Premeditazioni, potenze, destinazioni volute vi elaborano in comune un’opera smisurata. Una vita terribile e orribile è lì dentro. Ci sono vaste evoluzioni di astri, la famiglia stellare, la famiglia planetaria, il polline zodiacale, il quid divinum delle correnti, delle emanazioni, delle polarizzazioni e delle attrazioni; ci sono l’abbraccio e il contrasto, uno stupendo flusso e riflusso di antitesi universale, l’imponderabile in libertà in mezzo ai centri; ci sono la linfa dei globi, la luce fuori dai globi, l’atomo errante, il germe sparso, curve di fecondazione, incontri di accoppiamento e di lotta, profusioni inaudite, distanze che somigliano a sogni, circolazioni vertiginose, sprofondamenti di mondi nell’incalcolabile, prodigi che si inseguono nelle tenebre, un meccanismo solo: soffi di sfere che fuggono, ruote dei cui giri è possibile ascoltare il rumore. Il dotto fa ipotesi, l’ignorante consente e trema. È una cosa che esiste e che sfugge: è l’inespugnabile; è fuor di portata, fuori da qualunque avvicinamento. Rimaniamo convinti fino all’oppressione. Non so quale nera evidenza ci sovrasta. Non possiamo afferrare nulla. Siamo schiacciati dall’impalpabile.
Ovunque l’incomprensibile; l’intelligibile in nessun luogo.
Aggiungete a tutto ciò la temibile domanda: “È un Essere quella Immanenza?”.
Siamo sotto l’Ombra. Guardiamo. Ascoltiamo.
Intanto, la cupa terra cammina e gira. I fiori hanno conoscenza di questo movimento enorme: la silena si schiude alle undici di notte e l’emerocallide alle cinque del mattino. Regolarità impressionanti? In altre profondità la goccia d’acqua diviene un mondo, l’infusorio pullula, la fecondità gigantesca esce dall’animaletto infinitesimale, l’impercettibile fa mostra della sua grandezza, si manifesta il senso inverso dell’immensità; una diatomea in un’ora produce mille e trecento milioni di diatomee.
Quale proposta di tutti gli enigmi insieme!
Là è l’irriducibile.
Siamo costretti alla fede. Il risultato è credere per forza. Ma aver fede non basta per sentirsi tranquilli. La fede ha non so quale strano bisogno di forma. Da ciò le religioni. Niente opprime come una credenza priva di limiti.
Comunque si pensi, qualunque cosa si voglia, qualunque sia la resistenza che possiamo avere in noi stessi, guardare l’oscurità non è guardare, è contemplare.
Che fare di quei fenomeni? Come muoversi sotto la loro convergenza? È impossibile decomporre quella pressione. Quale fantasticheria adattare a tutte quelle misteriose conclusioni? Quante rivelazioni astruse, simultanee, indecise, che si fanno oscure per il loro stesso numero, specie di balbettii del verbo! L’oscurità è un silenzio, ma quel silenzio dice tutto. Una risultante balza maestosa da essa: Dio. Dio è la nozione incomprensibile. Essa è nell’uomo. I sillogismi, le dispute, le negazioni, i sistemi, le religioni le passano sopra senza diminuirla. E l’oscurità afferma intera questa nozione. Ma, sopra tutto il resto, è il turbamento. Immanenza formidabile. L’inesprimibile accordo delle forze si manifesta col mantenimento in equilibrio di tutta quella tenebra. L’universo è sospeso e nulla cade. Lo spostamento incessante e smisurato si compie senza accidenti e senza lesioni. L’uomo partecipa a quel movimento di traslazione e chiama destino la quantità d’oscillazione che subisce. Dove comincia il destino? Dove finisce la natura? Quale differenza passa tra un avvenimento e una stagione, tra un dolore e una pioggia, tra una virtù e una stella? Un’ora non è forse un’onda? Gli ingranaggi in moto continuano la loro rivoluzione impassibile senza rispondere all’uomo. Il cielo stellato è una visione di ruote, di bilancieri e di contrappesi. È la contemplazione suprema cui si aggiunge la suprema meditazione. È tutta la realtà più tutta l’astrazione. Null’altro più. Ci sentiamo presi. Siamo in balia di quell’oscurità. Non è possibile alcuna fuga. Ci vediamo nell’ingranaggio, siamo parte integrante di un Tutto ignorato, sentiamo l’ignoto che è in noi fraternizzare misteriosamente con un ignoto che è fuori di noi. Questo è l’annuncio sublime della morte.
Quale angoscia e, nel tempo stesso, quale incanto! Aderire all’infinito, essere indotti da quell’aderenza ad attribuire a se stessi un’immortalità necessaria – chi sa? – una possibile eternità, sentire nel flutto prodigioso di quel diluvio di vita universale la tenacia irriducibile dell’Io! Guardare le stelle e dire: “Io sono un’anima come voi!”; guardare l’oscurità e dire: “Io sono un abisso come te!”.
Tali enormità formano la notte.
Tutto questo, accresciuto dalla solitudine, pesava su Gilliat.
Lo comprendeva lui? No.
Lo sentiva? Sì.
Gilliat era un grande spirito offuscato e un grande cuore selvaggio.
"SUB UMBRA”
A volte, di notte, Gilliat apriva gli occhi e guardava le tenebre.
Si sentiva stranamente commosso.
L’occhio aperto nel buio. Situazione lugubre; ansia.
La pressione dell’ombra esiste.
Un’indefinibile soffitto di tenebre, un’alta oscurità nella quale è impossibile penetrare; frammista a quell’oscurità, una non so che luce, vinta e cupa. Chiarore ridotto in polvere. È seme? È cenere? Milioni di fiaccole senza la minima illuminazione: un vasto fiammeggiare che non svela il suo segreto; un diffondersi di fuoco polverizzato che sembra un volo di scintille arrestato. Il disordine del turbine e l’immobilità del sepolcro; il problema che offre una soluzione da precipizio; l’enigma che mostra e nasconde il suo volto; l’infinito mascherato di nero: ecco la Notte. Tale sovrapposizione è pesante per l’uomo.
Quest’amalgama di tutti i misteri, dal cosmico al fatale, opprime il cervello umano.
La pressione delle tenebre agisce in senso inverso sulle diverse specie di anime. L’uomo, davanti alla notte, si riconosce incompleto. Vede il buio e sente l’infermità. Il cielo nero è l’uomo cieco. L’uomo, a faccia a faccia con la notte, si abbatte, si inginocchia, si prosterna, si distende bocconi, striscia verso un rifugio o si cerca delle ali. Quasi sempre egli vuol fuggire l’informe presenza dell’Ignoto. Si domanda che cosa sia, trema, si china, ignora e, talvolta anche, vuole andargli incontro.
Incontro dove?
Là!
Là? Che cos’è? E che cosa c’è?
Tale curiosità è evidentemente quella delle cose proibite, perché da questo lato tutti i ponti sono rotti intorno all’uomo. Manca l’arco dell’infinito. Ma ciò che è proibito attira, perché è abisso. Dove non va il piede, può giungere lo sguardo; dove lo sguardo si arresta, può proseguire lo spirito. Non c’è uomo che non tenti, per quanto debole e insufficiente sia. A seconda della sua natura, l’uomo è in cerca o in arresto davanti alla notte. Per alcuni è una compressione, per altri una dilatazione. Lo spettacolo è cupo. Vi si mischia l’indefinibile.
La notte è serena? È un fondo d’ombra. È tempestosa? È un fondo di fumo. L’illimitato si offre e si rifiuta nel tempo stesso, chiuso all’esperimento, aperto all’ipotesi. Innumerevoli punteggiature di luce rendono più nera l’oscurità senza fondo: gemme, scintillii di astri, presenze accertate nell’ignoto, spaventose sfide ad andare a toccar quelle luci. Sono segnali di creazione nell’assoluto; limiti di distanza là dove non ci sono più distanze; è una non so quale numerazione impossibile, e tuttavia reale, dei gradi delle profondità. Un punto microscopico che brilla, poi un altro, poi ancora un altro: è l’impercettibile, l’enorme. Quella luce è un focolare, quel focolare è una stella, quella stella è un sole, quel sole è un universo, quell’universo non è nulla.
Ogni numero è zero di fronte all’infinito.
Quegli universi, che non sono nulla, esistono. Nell’osservarli si sente la differenza che passa tra l’essere nulla e il non essere.
L’inaccessibile aggiunto all’impenetrabile, l’impenetrabile aggiunto all’inesplicabile; ecco che cos’è il cielo.
Da tale contemplazione deriva un fenomeno sublime: l’ingrandimento dell’anima per mezzo dello stupore.
Il terrore sacro è proprio dell’uomo. La bestia non conosce questo genere di paura. L’intelligenza ha, in tale augusta paura, la sua eclisse e la sua prova.
L’oscurità è una: da ciò l’errore. E, al tempo stesso, è complessa: di qui lo spavento. La sua unità fa massa sul nostro spirito e toglie il desiderio di resistere. La sua complessità fa sì che noi ci guardiamo d’intorno da tutti i lati e ci pare di dover temere bruschi assalti. Ci arrendiamo e ci guardiamo. Siamo in presenza di Tutto: da ciò la sottomissione; e di Molti: da ciò la diffidenza. L’unità dell’ombra contiene un multiplo. Multiplo misterioso, visibile nella materia, sensibile nel pensiero. Esso tace: motivo di più per stare in guardia.
La notte – chi scrive queste parole lo ha già detto altrove – è lo stato proprio e normale della creazione di cui facciamo parte. Il giorno, breve nella durata come nello spazio, non è che una misura stellare.
L’universale prodigio notturno non si compie senza attriti, e tutti gli attriti di una simile macchina sono delle contusioni per la vita. Ciò che noi chiamiamo Male sono appunto questi attriti della macchina. In quell’oscurità noi avvertiamo il Male come latente smentita all’ordine divino, bestemmia implicita del fatto ribelle all’ideale. Il Male complica di una indefinibile teratologia dalle mille teste l’immenso complesso cosmico. Il Male è presente ovunque per protestare. È uragano, e disturba la rotta di una nave; è caos, e intralcia la nascita di un mondo. Il Bene ha l’unità; il Male ha l’ubiquità. Il Male sconcerta la vita, che è una logica. Fa divorare la mosca dall’uccello e il pianeta dalla cometa. Il Male è una cancellatura fatta sulla creazione.
L’oscurità notturna è piena di una vertigine. Chi la approfondisce, si sommerge in essa e vi si dibatte. Nessuna fatica è paragonabile all’esame delle tenebre. È come lo studio di una cosa svanita.
Non c’è un posto definito sul quale appoggiare lo spirito. Punti di partenza privi di punti d’arrivo. L’incrociarsi delle soluzioni contradittorie, tutte le ramificazioni del dubbio che si offrono contemporaneamente, tutta la molteplicità dei fenomeni che si svolgono senza limiti per una indefinita generazione, tutte le leggi che si confondono l’una con l’altra, una promiscuità insondabile, la quale fa sì che la mineralizzazione vegeti, che la vegetazione viva, che il pensiero pesi, che l’amore risplenda e che la gravitazione ami; l’immensa fronte d’attacco di tutte le questioni che si sviluppano nell’oscurità illimitata; l’intravisto che abbozza l’ignorato; la simultaneità cosmica in piena apparizione, non per lo sguardo, ma per l’intelligenza, nel grande spazio indistinto; l’invisibile che diventa visione: ecco l’ombra. L’uomo è sotto di essa.
Non conosce i particolari; ma sopporta, in quantità proporzionata al suo spirito, il peso mostruoso dell’assieme. Tale ossessione spingeva i pastori della Caldea verso l’astronomia. Dai pori della creazione escono rivelazioni involontarie; si forma, in certo modo, un trasudamento di scienza e conquista l’ignorante. Ogni solitario, per effetto di tale penetrazione misteriosa, diviene spesso, senza rendersene conto, un filosofo; così, istintivamente.
L’oscurità è indivisibile. È abitata. Abitata senza spostamento da parte dell’Assoluto; abitata anche con spostamento. Qualche cosa si muove in essa. Una formazione sacra vi compie le sue fasi. Premeditazioni, potenze, destinazioni volute vi elaborano in comune un’opera smisurata. Una vita terribile e orribile è lì dentro. Ci sono vaste evoluzioni di astri, la famiglia stellare, la famiglia planetaria, il polline zodiacale, il quid divinum delle correnti, delle emanazioni, delle polarizzazioni e delle attrazioni; ci sono l’abbraccio e il contrasto, uno stupendo flusso e riflusso di antitesi universale, l’imponderabile in libertà in mezzo ai centri; ci sono la linfa dei globi, la luce fuori dai globi, l’atomo errante, il germe sparso, curve di fecondazione, incontri di accoppiamento e di lotta, profusioni inaudite, distanze che somigliano a sogni, circolazioni vertiginose, sprofondamenti di mondi nell’incalcolabile, prodigi che si inseguono nelle tenebre, un meccanismo solo: soffi di sfere che fuggono, ruote dei cui giri è possibile ascoltare il rumore. Il dotto fa ipotesi, l’ignorante consente e trema. È una cosa che esiste e che sfugge: è l’inespugnabile; è fuor di portata, fuori da qualunque avvicinamento. Rimaniamo convinti fino all’oppressione. Non so quale nera evidenza ci sovrasta. Non possiamo afferrare nulla. Siamo schiacciati dall’impalpabile.
Ovunque l’incomprensibile; l’intelligibile in nessun luogo.
Aggiungete a tutto ciò la temibile domanda: “È un Essere quella Immanenza?”.
Siamo sotto l’Ombra. Guardiamo. Ascoltiamo.
Intanto, la cupa terra cammina e gira. I fiori hanno conoscenza di questo movimento enorme: la silena si schiude alle undici di notte e l’emerocallide alle cinque del mattino. Regolarità impressionanti? In altre profondità la goccia d’acqua diviene un mondo, l’infusorio pullula, la fecondità gigantesca esce dall’animaletto infinitesimale, l’impercettibile fa mostra della sua grandezza, si manifesta il senso inverso dell’immensità; una diatomea in un’ora produce mille e trecento milioni di diatomee.
Quale proposta di tutti gli enigmi insieme!
Là è l’irriducibile.
Siamo costretti alla fede. Il risultato è credere per forza. Ma aver fede non basta per sentirsi tranquilli. La fede ha non so quale strano bisogno di forma. Da ciò le religioni. Niente opprime come una credenza priva di limiti.
Comunque si pensi, qualunque cosa si voglia, qualunque sia la resistenza che possiamo avere in noi stessi, guardare l’oscurità non è guardare, è contemplare.
Che fare di quei fenomeni? Come muoversi sotto la loro convergenza? È impossibile decomporre quella pressione. Quale fantasticheria adattare a tutte quelle misteriose conclusioni? Quante rivelazioni astruse, simultanee, indecise, che si fanno oscure per il loro stesso numero, specie di balbettii del verbo! L’oscurità è un silenzio, ma quel silenzio dice tutto. Una risultante balza maestosa da essa: Dio. Dio è la nozione incomprensibile. Essa è nell’uomo. I sillogismi, le dispute, le negazioni, i sistemi, le religioni le passano sopra senza diminuirla. E l’oscurità afferma intera questa nozione. Ma, sopra tutto il resto, è il turbamento. Immanenza formidabile. L’inesprimibile accordo delle forze si manifesta col mantenimento in equilibrio di tutta quella tenebra. L’universo è sospeso e nulla cade. Lo spostamento incessante e smisurato si compie senza accidenti e senza lesioni. L’uomo partecipa a quel movimento di traslazione e chiama destino la quantità d’oscillazione che subisce. Dove comincia il destino? Dove finisce la natura? Quale differenza passa tra un avvenimento e una stagione, tra un dolore e una pioggia, tra una virtù e una stella? Un’ora non è forse un’onda? Gli ingranaggi in moto continuano la loro rivoluzione impassibile senza rispondere all’uomo. Il cielo stellato è una visione di ruote, di bilancieri e di contrappesi. È la contemplazione suprema cui si aggiunge la suprema meditazione. È tutta la realtà più tutta l’astrazione. Null’altro più. Ci sentiamo presi. Siamo in balia di quell’oscurità. Non è possibile alcuna fuga. Ci vediamo nell’ingranaggio, siamo parte integrante di un Tutto ignorato, sentiamo l’ignoto che è in noi fraternizzare misteriosamente con un ignoto che è fuori di noi. Questo è l’annuncio sublime della morte.
Quale angoscia e, nel tempo stesso, quale incanto! Aderire all’infinito, essere indotti da quell’aderenza ad attribuire a se stessi un’immortalità necessaria – chi sa? – una possibile eternità, sentire nel flutto prodigioso di quel diluvio di vita universale la tenacia irriducibile dell’Io! Guardare le stelle e dire: “Io sono un’anima come voi!”; guardare l’oscurità e dire: “Io sono un abisso come te!”.
Tali enormità formano la notte.
Tutto questo, accresciuto dalla solitudine, pesava su Gilliat.
Lo comprendeva lui? No.
Lo sentiva? Sì.
Gilliat era un grande spirito offuscato e un grande cuore selvaggio.
Esercitazioni
Osservare la strada, di tanto in tanto, magari con una cura un po’ sistematica.
Applicarsi, fare tutto con calma.
Annotare il luogo: i tavolini di un caffè vicino all’incrocio Bac-Saint-Germain
l’ora: le sette di sera
la data: 15 maggio 1973
il tempo: bello stabile
Annotare quello che si vede. Quello che succede di notevole. Sappiamo vedere quello che è notevole? C’è qualcosa che ci colpisce?
Niente ci colpisce. Non sappiamo vedere.
Bisogna procedere più lentamente, quasi stupidamente.
Sforzarsi di scrivere cose prive d’interesse, quelle più ovvie, più comuni, più scialbe.
Costringersi a vedere più piattamente.
Percepire un ritmo.
Decifrare un pezzo di città. I suoi circuiti: perché gli autobus vanno da tale posto a tal altro? Chi sceglie gli itinerari e in funzione di cosa?
La gente nelle strade: da dove vengono? Dove vanno? Chi sono? Gente che ha fretta. Gente lenta. Pacchetti. Gente prudente che ha preso l’impermeabile. Cani: sono gli unici animali visibili.
Un cane, di una specie rara (levriero afgano? levriero africano?)
Una land-rover che sembra attrezzata per attraversare il Sahara (nostro malgrado, notiamo solo l’insolito, lo speciale, il miseramente eccezionale: è proprio il contrario che si dovrebbe fare).
Continuare.
Finchè il luogo diventi improbabile, fino a provare, per un breve istante, l’impressione di essere in una città straniera, o meglio ancora, fino a non capire più che cosa succeda e che cosa non succeda, finché il luogo intero divenga estraneo, e non si sappia che tutto questo si chiama città, strada, palazzi, marciapiedi…
Far piovere piogge diluviali, rompere tutto, far crescere l’erba, sostituire la gente con delle mucche, veder apparire, cento metri al di sopra dei palazzi, King-Kong, o il topolino ingigantito di Tex Avery!
O anche: sforzarsi di immaginare il più precisamente possibile, sotto la rete stradale, il groviglio delle fognature, il passaggio delle linee del metrò, la proliferazione invisibile e sotterranea dei condotti (elettricità, gas, linee telefoniche, condutture dell’acqua, rete della posta pneumatica) senza la quale non ci sarebbe traccia di vita in superficie.
Sotto, proprio al di sotto, resuscitare l’eocene: il calcare da molare, le marne e il pietrisco, il gesso, le sabbie e le ligniti, l’argilla plastica, la creta.

Osservare la strada, di tanto in tanto, magari con una cura un po’ sistematica.
Applicarsi, fare tutto con calma.
Annotare il luogo: i tavolini di un caffè vicino all’incrocio Bac-Saint-Germain
l’ora: le sette di sera
la data: 15 maggio 1973
il tempo: bello stabile
Annotare quello che si vede. Quello che succede di notevole. Sappiamo vedere quello che è notevole? C’è qualcosa che ci colpisce?
Niente ci colpisce. Non sappiamo vedere.
Bisogna procedere più lentamente, quasi stupidamente.
Sforzarsi di scrivere cose prive d’interesse, quelle più ovvie, più comuni, più scialbe.
Costringersi a vedere più piattamente.
Percepire un ritmo.
Decifrare un pezzo di città. I suoi circuiti: perché gli autobus vanno da tale posto a tal altro? Chi sceglie gli itinerari e in funzione di cosa?
La gente nelle strade: da dove vengono? Dove vanno? Chi sono? Gente che ha fretta. Gente lenta. Pacchetti. Gente prudente che ha preso l’impermeabile. Cani: sono gli unici animali visibili.
Un cane, di una specie rara (levriero afgano? levriero africano?)
Una land-rover che sembra attrezzata per attraversare il Sahara (nostro malgrado, notiamo solo l’insolito, lo speciale, il miseramente eccezionale: è proprio il contrario che si dovrebbe fare).
Continuare.
Finchè il luogo diventi improbabile, fino a provare, per un breve istante, l’impressione di essere in una città straniera, o meglio ancora, fino a non capire più che cosa succeda e che cosa non succeda, finché il luogo intero divenga estraneo, e non si sappia che tutto questo si chiama città, strada, palazzi, marciapiedi…
Far piovere piogge diluviali, rompere tutto, far crescere l’erba, sostituire la gente con delle mucche, veder apparire, cento metri al di sopra dei palazzi, King-Kong, o il topolino ingigantito di Tex Avery!
O anche: sforzarsi di immaginare il più precisamente possibile, sotto la rete stradale, il groviglio delle fognature, il passaggio delle linee del metrò, la proliferazione invisibile e sotterranea dei condotti (elettricità, gas, linee telefoniche, condutture dell’acqua, rete della posta pneumatica) senza la quale non ci sarebbe traccia di vita in superficie.
Sotto, proprio al di sotto, resuscitare l’eocene: il calcare da molare, le marne e il pietrisco, il gesso, le sabbie e le ligniti, l’argilla plastica, la creta.

non ho capito se bisogna limitarsi alle nuove uscite o a quanto si sta leggendo nel 2021 comunque sia.
Comunque sia, per togliersi scaramanticamente dal message 17
Billy guardò l’orologio sul fornello a gas. Aveva un’ora da passare prima che arrivasse il disco volante. Andò nel soggiorno, dondolando la bottiglia come una campanella per il pranzo, e accese la televisione. Cominciò a perdere la nozione del tempo, vide il film della notte dalla fine, poi ancora dall’inizio. Era un film sui bombardieri americani durante la Seconda guerra mondiale e sui loro coraggiosi equipaggi. Vista a rovescio da Billy, la storia era questa:
Gli aerei americani, pieni di fori e di feriti e di cadaveri decollavano all’indietro da un campo d’aviazione in Inghilterra. Quando furono sopra la Francia, alcuni caccia tedeschi li raggiunsero, sempre volando all’indietro, e succhiarono proiettili e schegge da alcuni degli aerei e degli aviatori. Fecero lo stesso con alcuni bombardieri americani distrutti, che erano a terra e poi decollarono all’indietro, per unirsi alla formazione.
Lo stormo, volando all’indietro, sorvolò una città tedesca in fiamme. I bombardieri aprirono i portelli del vano bombe, esercitarono un miracoloso magnetismo che ridusse gli incendi e li raccolse in recipienti cilindrici d’acciaio, e sollevarono questi recipienti fino a farli sparire nel ventre degli aerei. I contenitori furono sistemati ordinatamente su alcune rastrelliere. Anche i tedeschi, là sotto, avevano degli strumenti portentosi, costituiti da lunghi tubi di acciaio. Li usavano per succhiare altri frammenti dagli aviatori e dagli aerei. Ma c’erano ancora degli americani feriti, e qualche bombardiere era gravemente danneggiato. Sopra la Francia, però, i caccia tedeschi tornarono ad alzarsi e rimisero tutti e tutto a nuovo.
Quando i bombardieri tornarono alla base, i cilindri d’acciaio furono tolti dalle rastrelliere e rimandati negli Stati Uniti, dove c’erano degli stabilimenti impegnati giorno e notte a smantellarli, a separarne il pericoloso contenuto e a riportarlo allo stato di minerale. Cosa commovente, erano soprattutto donne a fare questo lavoro. I minerali venivano poi spediti a specialisti in zone remote. Là dovevano rimetterli nel terreno e nasconderli per bene in modo che non potessero mai più fare male a nessuno.
Gli aviatori americani lasciarono l’uniforme e diventarono dei ragazzi. E Hitler, pensò Billy, divenne un bambino. Questo nel film non c’era. Billy stava estrapolando. Tutti tornarono bambini, e tutta l’umanità, senza eccezione, cooperò biologicamente fino a produrre due individui perfetti di nome Adamo ed Eva.

Comunque sia, per togliersi scaramanticamente dal message 17
Billy guardò l’orologio sul fornello a gas. Aveva un’ora da passare prima che arrivasse il disco volante. Andò nel soggiorno, dondolando la bottiglia come una campanella per il pranzo, e accese la televisione. Cominciò a perdere la nozione del tempo, vide il film della notte dalla fine, poi ancora dall’inizio. Era un film sui bombardieri americani durante la Seconda guerra mondiale e sui loro coraggiosi equipaggi. Vista a rovescio da Billy, la storia era questa:
Gli aerei americani, pieni di fori e di feriti e di cadaveri decollavano all’indietro da un campo d’aviazione in Inghilterra. Quando furono sopra la Francia, alcuni caccia tedeschi li raggiunsero, sempre volando all’indietro, e succhiarono proiettili e schegge da alcuni degli aerei e degli aviatori. Fecero lo stesso con alcuni bombardieri americani distrutti, che erano a terra e poi decollarono all’indietro, per unirsi alla formazione.
Lo stormo, volando all’indietro, sorvolò una città tedesca in fiamme. I bombardieri aprirono i portelli del vano bombe, esercitarono un miracoloso magnetismo che ridusse gli incendi e li raccolse in recipienti cilindrici d’acciaio, e sollevarono questi recipienti fino a farli sparire nel ventre degli aerei. I contenitori furono sistemati ordinatamente su alcune rastrelliere. Anche i tedeschi, là sotto, avevano degli strumenti portentosi, costituiti da lunghi tubi di acciaio. Li usavano per succhiare altri frammenti dagli aviatori e dagli aerei. Ma c’erano ancora degli americani feriti, e qualche bombardiere era gravemente danneggiato. Sopra la Francia, però, i caccia tedeschi tornarono ad alzarsi e rimisero tutti e tutto a nuovo.
Quando i bombardieri tornarono alla base, i cilindri d’acciaio furono tolti dalle rastrelliere e rimandati negli Stati Uniti, dove c’erano degli stabilimenti impegnati giorno e notte a smantellarli, a separarne il pericoloso contenuto e a riportarlo allo stato di minerale. Cosa commovente, erano soprattutto donne a fare questo lavoro. I minerali venivano poi spediti a specialisti in zone remote. Là dovevano rimetterli nel terreno e nasconderli per bene in modo che non potessero mai più fare male a nessuno.
Gli aviatori americani lasciarono l’uniforme e diventarono dei ragazzi. E Hitler, pensò Billy, divenne un bambino. Questo nel film non c’era. Billy stava estrapolando. Tutti tornarono bambini, e tutta l’umanità, senza eccezione, cooperò biologicamente fino a produrre due individui perfetti di nome Adamo ed Eva.

Andrea wrote: "non ho capito se bisogna limitarsi alle nuove uscite o a quanto si sta leggendo nel 2021 comunque sia.
Comunque sia, per togliersi scaramanticamente dal message 17
Nessun limite di uscita, potete tranquillamente aggiungere tutte le citazioni o i libri che vi piacciono. Grazie per averci tolto dal pericoloso 17!
Comunque sia, per togliersi scaramanticamente dal message 17
Nessun limite di uscita, potete tranquillamente aggiungere tutte le citazioni o i libri che vi piacciono. Grazie per averci tolto dal pericoloso 17!
Azzurro e madreperla
Per me, la lunga a dell'alfabeto inglese (ed è questo l'alfabeto che tengo presente da qui in avanti, a meno che non segnali altrimenti) assume la tinta del legno stagionato, ma una a francese mi evoca l'ebano lucente. La gamma dei neri comprende anche la g dura (gomma vulcanizzata) e la r (un cencio fuligginoso che viene lacerato). Il porridge della n, i flaccidi spaghetti della l e lo specchio dal dorso d'avorio della o coprono la gamma dei bianchi. Resto perplesso davanti al mio on francese, che vedo come la tensione superficiale del liquore che riempie un bicchierino fino all'orlo. Passando al gruppo dei blu, ecco l'acciaio di una x, la nube temporalesca della z, e il mirtillo della k. Dato che tra suono e forma esiste una sottile interazione, vedo la q più marrone della k, mentre il celeste della s non è quello della c, ma un curioso miscuglio di azzurro e madreperla. Le tinte contigue non si fondono e i dittonghi non hanno colori propri, a meno che non siano rappresentati da un unico carattere in qualche altra lingua (così il grigio vaporoso della lettera russa a tre zampe che rende il suono s, lettera lettera antica quanto le rapide del Nilo, ne influenza la rappresentazione in inglese).

Prima di venire interrotto mi affretto a completare la lista. Nel gruppo dei verdi c'è la foglia di ontano della f, la mela acerba della p e il pistacchio della t. Un verde opaco frammisto in qualche modo al violetto è quanto di meglio io riesca a fare per la w. I gialli comprendono varie e e i, la cremosa d, l'orosplendente della y, e la u, il cui valore alfabetico posso solo esprimere come «ottone con riflessi oliva». Il gruppo dei marroni comprende i ricchi toni gommosi della g dolce, quelli più pallidi della j, e lo sfibrato laccio da scarpe della h. Infine, tra i rossi, la b ha quella sfumatura che i pittori chiamano terra di Siena, la m è un panneggio di flanella rosa, e oggi ho finalmente abbinato alla perfezione la v con il del Dizionario del colore di Maerz e Paul Nella mia lingua privata, la parola che sta per arcobaleno - un arcobaleno di colori primari ma decisamente smorti - è difficilmente pronunciabile:
kzspygu. Il primo che si occupò di audition colorée fu, per quanto ne so, un medico albino di Erlangen, nel 1812.
Per me, la lunga a dell'alfabeto inglese (ed è questo l'alfabeto che tengo presente da qui in avanti, a meno che non segnali altrimenti) assume la tinta del legno stagionato, ma una a francese mi evoca l'ebano lucente. La gamma dei neri comprende anche la g dura (gomma vulcanizzata) e la r (un cencio fuligginoso che viene lacerato). Il porridge della n, i flaccidi spaghetti della l e lo specchio dal dorso d'avorio della o coprono la gamma dei bianchi. Resto perplesso davanti al mio on francese, che vedo come la tensione superficiale del liquore che riempie un bicchierino fino all'orlo. Passando al gruppo dei blu, ecco l'acciaio di una x, la nube temporalesca della z, e il mirtillo della k. Dato che tra suono e forma esiste una sottile interazione, vedo la q più marrone della k, mentre il celeste della s non è quello della c, ma un curioso miscuglio di azzurro e madreperla. Le tinte contigue non si fondono e i dittonghi non hanno colori propri, a meno che non siano rappresentati da un unico carattere in qualche altra lingua (così il grigio vaporoso della lettera russa a tre zampe che rende il suono s, lettera lettera antica quanto le rapide del Nilo, ne influenza la rappresentazione in inglese).

Prima di venire interrotto mi affretto a completare la lista. Nel gruppo dei verdi c'è la foglia di ontano della f, la mela acerba della p e il pistacchio della t. Un verde opaco frammisto in qualche modo al violetto è quanto di meglio io riesca a fare per la w. I gialli comprendono varie e e i, la cremosa d, l'orosplendente della y, e la u, il cui valore alfabetico posso solo esprimere come «ottone con riflessi oliva». Il gruppo dei marroni comprende i ricchi toni gommosi della g dolce, quelli più pallidi della j, e lo sfibrato laccio da scarpe della h. Infine, tra i rossi, la b ha quella sfumatura che i pittori chiamano terra di Siena, la m è un panneggio di flanella rosa, e oggi ho finalmente abbinato alla perfezione la v con il del Dizionario del colore di Maerz e Paul Nella mia lingua privata, la parola che sta per arcobaleno - un arcobaleno di colori primari ma decisamente smorti - è difficilmente pronunciabile:
kzspygu. Il primo che si occupò di audition colorée fu, per quanto ne so, un medico albino di Erlangen, nel 1812.
I nemici del retino - Selvaggi ululati di sbeffeggiamento si sono levati da macchine in corsa sulle autostrade; cani sonnacchiosi, indifferenti ai peggiori barboni, si sono ringalluzziti e mi si sono avventati contro ringhiando; bimbetti mi hanno additato alle loro mamme perplesse; villeggianti di ampie vedute mi hanno chiesto se cercassi esche per i pesci; e un certo mattino, in una landa illuminata da alte yucche in fiore, vicino a Santa Fe, una grossa giumenta nera mi seguì per più di due chilometri.

Ho inoltre scoperto ben presto come un «lepidista» che si dedica alla sua tranquilla ricerca corra il rischio di provocare strane reazioni in altre creature. Quante volte, dopo che avevano organizzato un picnic, e io con un certo imbarazzo e senza farmi notare cercavo di infilare i miei umili attrezzi nel torpedone per le gite che sapeva di catrame (per tenere le mosche lontane dai cavalli veniva usato appunto un preparato al catrame), o nella Opel decappottabile che sapeva di tè (tale era l'odore della benzina quarantanni fa), una qualche zia o cugina osservava: «Devi proprio portarti dietro quel retino? Non ti puoi divertire come un ragazzo normale? Non pensi che stai rovinando la festa a tutti?».
Accanto a un cartello NACH BODENLAUBE a Bad Kissingen, in Baviera, mentre mi accingevo a una lunga passeggiata con mio padre e il vecchio maestoso Muromcev (che, quattro anni prima, nel 1906, era stato presidente della Prima Duma), quest'ultimo girò il capo marmoreo verso di me, vulnerabile ragazzino di undici anni, e mi disse con la solennità per cui era famoso: «Vieni pure con noi, ma non acchiappare farfalle, piccolo. Guasta il ritmo della passeggiata».
Nel marzo del 1918, in Crimea, su un viottolo che dominava il Mar Nero, in mezzo a una cerea fioritura di arbusti, una sentinella bolscevica dalle gambe arcuate si provò ad arrestarmi per aver fatto segnalazioni (con il retino, diceva) a una nave da guerra inglese. Nell'estate del 1929, ogni volta che, attraversando a piedi un villaggio dei Pirenei orientali, mi voltavo indietro, vedevo sulle mie tracce la gente del luogo, impietrita nelle diverse pose in cui era stata nelle diverse pose in cui era stata sorpresa dal mio passaggio, come se io fossi Sodoma e loro la moglie di Lot. Un decennio dopo, sulle Alpi Marittime, mi capitò di osservare un serpentino ondeggiare d'erba alle mie spalle, provocato da una grassa guardia campestre che mi braccava strisciando sul ventre per accertarsi che non stessi acchiappando uccelli canterini.
L'America ha dimostrato, per le mie attività retiformi, un interesse morboso ancora maggiore di quello degli altri paesi, forse perché quando venni a vivere qui ero sulla quarantina, e quanto più vecchio sei tanto più strano sembri con un retino in mano. Intransigenti agricoltori hanno attirato la mia attenzione su cartelli che dicevano VIETATA LA PESCA; selvaggi ululati di sbeffeggiamento si sono levati da macchine in corsa sulle autostrade; cani sonnacchiosi, indifferenti ai peggiori barboni, si sono ringalluzziti e mi si sono avventati contro ringhiando; bimbetti mi hanno additato alle loro mamme perplesse; villeggianti di ampie vedute mi hanno chiesto se cercassi esche per i pesci; e un certo mattino, in una landa illuminata da alte yucche in fiore, vicino a Santa Fe, una grossa giumenta nera mi seguì per più di due chilometri.

Ho inoltre scoperto ben presto come un «lepidista» che si dedica alla sua tranquilla ricerca corra il rischio di provocare strane reazioni in altre creature. Quante volte, dopo che avevano organizzato un picnic, e io con un certo imbarazzo e senza farmi notare cercavo di infilare i miei umili attrezzi nel torpedone per le gite che sapeva di catrame (per tenere le mosche lontane dai cavalli veniva usato appunto un preparato al catrame), o nella Opel decappottabile che sapeva di tè (tale era l'odore della benzina quarantanni fa), una qualche zia o cugina osservava: «Devi proprio portarti dietro quel retino? Non ti puoi divertire come un ragazzo normale? Non pensi che stai rovinando la festa a tutti?».
Accanto a un cartello NACH BODENLAUBE a Bad Kissingen, in Baviera, mentre mi accingevo a una lunga passeggiata con mio padre e il vecchio maestoso Muromcev (che, quattro anni prima, nel 1906, era stato presidente della Prima Duma), quest'ultimo girò il capo marmoreo verso di me, vulnerabile ragazzino di undici anni, e mi disse con la solennità per cui era famoso: «Vieni pure con noi, ma non acchiappare farfalle, piccolo. Guasta il ritmo della passeggiata».
Nel marzo del 1918, in Crimea, su un viottolo che dominava il Mar Nero, in mezzo a una cerea fioritura di arbusti, una sentinella bolscevica dalle gambe arcuate si provò ad arrestarmi per aver fatto segnalazioni (con il retino, diceva) a una nave da guerra inglese. Nell'estate del 1929, ogni volta che, attraversando a piedi un villaggio dei Pirenei orientali, mi voltavo indietro, vedevo sulle mie tracce la gente del luogo, impietrita nelle diverse pose in cui era stata nelle diverse pose in cui era stata sorpresa dal mio passaggio, come se io fossi Sodoma e loro la moglie di Lot. Un decennio dopo, sulle Alpi Marittime, mi capitò di osservare un serpentino ondeggiare d'erba alle mie spalle, provocato da una grassa guardia campestre che mi braccava strisciando sul ventre per accertarsi che non stessi acchiappando uccelli canterini.
L'America ha dimostrato, per le mie attività retiformi, un interesse morboso ancora maggiore di quello degli altri paesi, forse perché quando venni a vivere qui ero sulla quarantina, e quanto più vecchio sei tanto più strano sembri con un retino in mano. Intransigenti agricoltori hanno attirato la mia attenzione su cartelli che dicevano VIETATA LA PESCA; selvaggi ululati di sbeffeggiamento si sono levati da macchine in corsa sulle autostrade; cani sonnacchiosi, indifferenti ai peggiori barboni, si sono ringalluzziti e mi si sono avventati contro ringhiando; bimbetti mi hanno additato alle loro mamme perplesse; villeggianti di ampie vedute mi hanno chiesto se cercassi esche per i pesci; e un certo mattino, in una landa illuminata da alte yucche in fiore, vicino a Santa Fe, una grossa giumenta nera mi seguì per più di due chilometri.
Primo amore
Nei due mesi del nostro soggiorno a Biarritz, la passione per Colette quasi superò la passione per la Cleopatra. Dato che i miei genitori non erano molto propensi a frequentare i suoi, io la vedevo solo in spiaggia; ma pensavo sempre a lei. Se mi accorgevo che aveva pianto, provavo un impeto di pena impotente che faceva affiorare le lacrime anche ai miei occhi. Non ero in grado di annientare le zanzare che le avevano lasciato morsi sul fragile collo, ma potevo, e così fu, avere la meglio facendo a pugni con un ragazzino dai capelli rossi che era stato villano con lei. Mi regalava calde manciate di caramelle. Un giorno che ce ne stavamo tutti e due curvi sopra una stella marina e i boccoli di Colette mi solleticavano l'orecchio, si girò di colpo verso di me e mi baciò sulla guancia. L'emozione fu tale che non riuscii a dire se non «Ehi, scimmietta».

Nei due mesi del nostro soggiorno a Biarritz, la passione per Colette quasi superò la passione per la Cleopatra. Dato che i miei genitori non erano molto propensi a frequentare i suoi, io la vedevo solo in spiaggia; ma pensavo sempre a lei. Se mi accorgevo che aveva pianto, provavo un impeto di pena impotente che faceva affiorare le lacrime anche ai miei occhi. Non ero in grado di annientare le zanzare che le avevano lasciato morsi sul fragile collo, ma potevo, e così fu, avere la meglio facendo a pugni con un ragazzino dai capelli rossi che era stato villano con lei. Mi regalava calde manciate di caramelle. Un giorno che ce ne stavamo tutti e due curvi sopra una stella marina e i boccoli di Colette mi solleticavano l'orecchio, si girò di colpo verso di me e mi baciò sulla guancia. L'emozione fu tale che non riuscii a dire se non «Ehi, scimmietta».

Ritratto di nonna
In una fluttuante veste di seta e mezzi guanti a rete, più oggetto d'epoca che essere vivente, passava gran parte della vita su un sofà, facendosi aria con un ventaglio d'avorio. Teneva costantemente a portata di mano una scatola di boules de gomme o un bicchiere di latte di mandorla, come pure uno specchietto, data la sua abitudine di incipriarsi il viso quasi ogni ora con un grande piumino rosa, anche se il piccolo neo sullo zigomo continuava a trasparire attraverso tutta quella farina come un chicco di ribes. Nonostante l'apparenza languida della sua routine quotidiana, lei restava una donna di costituzione molto forte e si piccava di dormire con la finestra spalancata in ogni stagione. Una mattina, dopo una bufera durata tutta la notte, la cameriera la trovò sepolta da uno scintillante strato di neve che aveva ricoperto lei e il letto senza violare il salubre splendore del suo sonno. Voleva bene a una persona sola, la figlia minore, Nadezda Vonljarljarskij, per amore della quale vendette improvvisamente Batovo nel 1916: una transazione che, in quel periodo di crepuscolare riflusso della storia imperiale, non fu di giovamento a nessuno. Si lamentava con tutti i nostri parenti delle forze occulte che le avevano traviato quel figlio così dotato, inducendolo a disdegnare la «brillante» carriera al servizio dello zar, per altro seguita in precedenza dai suoi antenati. Quel che trovava difficile da capire era soprattutto il fatto che mio padre, pur apprezzando a fondo ogni piacere derivante da una grande ricchezza, potesse metterne a rischio il godimento diventando un liberale, e contribuendo così all'avvento di una rivoluzione che, alla lunga, come da lei correttamente previsto, lo avrebbe ridotto in miseria.

In una fluttuante veste di seta e mezzi guanti a rete, più oggetto d'epoca che essere vivente, passava gran parte della vita su un sofà, facendosi aria con un ventaglio d'avorio. Teneva costantemente a portata di mano una scatola di boules de gomme o un bicchiere di latte di mandorla, come pure uno specchietto, data la sua abitudine di incipriarsi il viso quasi ogni ora con un grande piumino rosa, anche se il piccolo neo sullo zigomo continuava a trasparire attraverso tutta quella farina come un chicco di ribes. Nonostante l'apparenza languida della sua routine quotidiana, lei restava una donna di costituzione molto forte e si piccava di dormire con la finestra spalancata in ogni stagione. Una mattina, dopo una bufera durata tutta la notte, la cameriera la trovò sepolta da uno scintillante strato di neve che aveva ricoperto lei e il letto senza violare il salubre splendore del suo sonno. Voleva bene a una persona sola, la figlia minore, Nadezda Vonljarljarskij, per amore della quale vendette improvvisamente Batovo nel 1916: una transazione che, in quel periodo di crepuscolare riflusso della storia imperiale, non fu di giovamento a nessuno. Si lamentava con tutti i nostri parenti delle forze occulte che le avevano traviato quel figlio così dotato, inducendolo a disdegnare la «brillante» carriera al servizio dello zar, per altro seguita in precedenza dai suoi antenati. Quel che trovava difficile da capire era soprattutto il fatto che mio padre, pur apprezzando a fondo ogni piacere derivante da una grande ricchezza, potesse metterne a rischio il godimento diventando un liberale, e contribuendo così all'avvento di una rivoluzione che, alla lunga, come da lei correttamente previsto, lo avrebbe ridotto in miseria.

L'infinità del mondo | Correre sui grandi quai che costeggiano la Senna, precipitarsi giù per le scalinate e schizzar via all'ombra del primo ponte, poi tornare a percorrere i viali nell'aria fresca della sera. Essere fuori di sé eppure sentirsi in sé dovunque scriveva Baudelaire.
Me ne sono andato spesso da Parigi, per poi puntualmente ritornarci. Sua è l'aria che ho respirato alla mia nascita, in avventure Bolivar, poi in quai Bourbon e ancora dopo in Avene Michel-Bizot. Lì, avrò avuto otto anni, mi sono riempito dell'odore zuccherino dei banchi di scuola, dell'odore del gesso e dei calamai. Ho corso e giocato all'ombra dei castagni del cortile. Ero il campione indiscusso di Shangai della mia classe. Ho sognato le grandi guerre di Francia, e ancor di più ho sognato sulle carte fluviali, sulle carte geologiche che mi svelavano i grezzi calcari luteziani e le candide falesie del Cretaceo.
Su Avenue Michel-Bizot ho visto un incendio per la prima volta. Le fiamme furiose e indomite guizzavano alte nel cielo, avvolgevano le case dal basso lasciandosi dietro scheletri di mura annerite. Quelle macerie fumanti mi hanno segnato più di qualsiasi altro evento. Da allora subisco il fascino delle rovine, dei muri scalcinati, della ruggine, dell'edera rampicante, delle ortiche: commoventi testimonianze della vanità delle cose.
Quando si è un bambino in pantaloncini bianchi, andare per le strade di Parigi significa prendere confidenza con l'infinità del mondo. Ogni marciapiede conduce a un altro marciapiede, un marciapiede che spunta all'angolo con un'altra strada che dà a sua volta su una strada ancora diversa. Correre sui grandi quai che costeggiano la Senna, precipitarsi giù per le scalinate e schizzar via all'ombra del primo ponte, poi tornare a percorrere i viali nell'aria fresca della sera. Essere fuori di sé eppure sentirsi in sé dovunque scriveva Baudelaire.


Me ne sono andato spesso da Parigi, per poi puntualmente ritornarci. Sua è l'aria che ho respirato alla mia nascita, in avventure Bolivar, poi in quai Bourbon e ancora dopo in Avene Michel-Bizot. Lì, avrò avuto otto anni, mi sono riempito dell'odore zuccherino dei banchi di scuola, dell'odore del gesso e dei calamai. Ho corso e giocato all'ombra dei castagni del cortile. Ero il campione indiscusso di Shangai della mia classe. Ho sognato le grandi guerre di Francia, e ancor di più ho sognato sulle carte fluviali, sulle carte geologiche che mi svelavano i grezzi calcari luteziani e le candide falesie del Cretaceo.
Su Avenue Michel-Bizot ho visto un incendio per la prima volta. Le fiamme furiose e indomite guizzavano alte nel cielo, avvolgevano le case dal basso lasciandosi dietro scheletri di mura annerite. Quelle macerie fumanti mi hanno segnato più di qualsiasi altro evento. Da allora subisco il fascino delle rovine, dei muri scalcinati, della ruggine, dell'edera rampicante, delle ortiche: commoventi testimonianze della vanità delle cose.
Quando si è un bambino in pantaloncini bianchi, andare per le strade di Parigi significa prendere confidenza con l'infinità del mondo. Ogni marciapiede conduce a un altro marciapiede, un marciapiede che spunta all'angolo con un'altra strada che dà a sua volta su una strada ancora diversa. Correre sui grandi quai che costeggiano la Senna, precipitarsi giù per le scalinate e schizzar via all'ombra del primo ponte, poi tornare a percorrere i viali nell'aria fresca della sera. Essere fuori di sé eppure sentirsi in sé dovunque scriveva Baudelaire.


L’onda nella mente | Lettera a Vita, 16 marzo 1926 | Per quanto riguarda il mot juste, sei in errore. Lo stile è una faccenda molto semplice; è tutta una questione di ritmo. Una volta trovato questo non puoi sbagliare le parole. Ma d’altra parte eccomi seduta qui da metà mattina, piena zeppa di idee, e visioni e quant’altro, senza riuscire a sloggiarne neanche mezza per la mancanza del giusto ritmo. L’essenza del ritmo è qualcosa di molto profondo, ben più recondito delle parole. Uno sguardo o un’emozione creano quest’onda nella mente ben prima che sorgano le parole adatte a esprimerla; e nella scrittura (tale è la mia convinzione attuale) bisogna ricreare quest’onda, e farla agire (il che in apparenza non ha niente a che vedere con le parole), e poi, quando irrompe e precipita nella mente, trovare le parole che le si confacciano. Ma non c’è dubbio che l’anno prossimo la penserò diversamente.
Dio Santo! Gita al faro! | A Vanessa Bell, domenica 15 maggio 1927 | Carissima, nessuna lettera da parte tua. Ma immagino bene come dev’essere andata. Scena: dopo cena. Nessa che cuce. Duncan che non fa assolutamente niente. Nessa: (posando di colpo il suo lavoro) Dio santo! Gita al faro! Ho letto solo fino a pagina 86 e in tutto sono ben 320. Come faccio a scrivere a Virginia...

Dio Santo! Gita al faro! | A Vanessa Bell, domenica 15 maggio 1927 | Carissima, nessuna lettera da parte tua. Ma immagino bene come dev’essere andata. Scena: dopo cena. Nessa che cuce. Duncan che non fa assolutamente niente. Nessa: (posando di colpo il suo lavoro) Dio santo! Gita al faro! Ho letto solo fino a pagina 86 e in tutto sono ben 320. Come faccio a scrivere a Virginia...

L’uva in gola Che grazia sarebbe non scrivere più, ma sdraiarsi sulla schiena in un vigneto e lasciarsi cadere l’uva in gola.
 🍇
🍇
 🍇
🍇
Maupassant often lunched at the restaurant in the tower, though he didn’t care much for the food: It’s the only place in Paris, he used to say, where I don’t have to see it. And it’s true that you must take endless precautions, in Paris, not to see the Eiffel Tower...
Maupassant often lunched at the restaurant in the tower, though he didn’t care much for the food: It’s the only place in Paris, he used to say, where I don’t have to see it. And it’s true that you must take endless precautions, in Paris, not to see the Eiffel Tower; whatever the season, through mist and cloud, on overcast days or in sunshine, in rain—wherever you are, whatever the landscape of roofs, domes, or branches separating you from it, the Tower is there; incorporated into daily life until you can no longer grant it any specific attribute, determined merely to persist, like a rock or the river, it is as literal as a phenomenon of nature whose meaning can be questioned to infinity but whose existence is incontestable. There is virtually no Parisian glance it fails to touch at some time of day; at the moment I begin writing these lines about it, the Tower is there, in front of me, framed by my window; and at the very moment the January night blurs it, apparently trying to make it invisible, to deny its presence, two little lights come on, winking gently as they revolve at its very tip: all this night too, it will be there, connecting me above Paris to each of my friends, that I know are seeing it: with it we all comprise a shifting figure of which it is the steady center: the Tower is friendly.

Maupassant often lunched at the restaurant in the tower, though he didn’t care much for the food: It’s the only place in Paris, he used to say, where I don’t have to see it. And it’s true that you must take endless precautions, in Paris, not to see the Eiffel Tower; whatever the season, through mist and cloud, on overcast days or in sunshine, in rain—wherever you are, whatever the landscape of roofs, domes, or branches separating you from it, the Tower is there; incorporated into daily life until you can no longer grant it any specific attribute, determined merely to persist, like a rock or the river, it is as literal as a phenomenon of nature whose meaning can be questioned to infinity but whose existence is incontestable. There is virtually no Parisian glance it fails to touch at some time of day; at the moment I begin writing these lines about it, the Tower is there, in front of me, framed by my window; and at the very moment the January night blurs it, apparently trying to make it invisible, to deny its presence, two little lights come on, winking gently as they revolve at its very tip: all this night too, it will be there, connecting me above Paris to each of my friends, that I know are seeing it: with it we all comprise a shifting figure of which it is the steady center: the Tower is friendly.

Contorni significanti
C’era un tempo in cui ammiravo la signorina Frizzi instancabilmente come chi abbia riconosciuto i meriti di una persona e non intende poi pentirsene mai. E lei naturalmente essendo insegnante di lingue estere non mi voleva smentire di questo fatto. Per ore dunque curava il ripasso delle mie cognizioni grammaticali entrambi comodamente seduti in un giardino forse non più adesso esistente della mia città. Io potevo anche dirle enormi strafalcionerie senza che lei si prendesse d’impazienza o gridasse per la grande comprensione del suo spirito. Nè passava giorno o due che non giungessi io al luogo dove sapevo trovarla ossia giardino pubblico ma non troppo frequentato recandole tra le mani un mazzo di fiori. Vuoi primule con reseda vuoi rose con altri contorni significanti cioè rispettivamente gioventù con dolcezza e beltà con altri pregi. E lei replicava a me spesso con offerte d’edera significante amicizia quando non con mammole significanti ma per scherzo s’intende pudore di modestia. Si può comprendere senza sforzo con quale trepidazione ogni dì mi incamminassi a detto luogo voglioso di ripassare lezioni eppure tanto pesanti per me. Ma per via c’era un vecchio simulante mendicità onde accrescere le sue ricchezze già nascoste il quale costui al vedermi con fiori nelle mani irrideva forte sempre...
Bibbia/Guizzardi/p.175

C’era un tempo in cui ammiravo la signorina Frizzi instancabilmente come chi abbia riconosciuto i meriti di una persona e non intende poi pentirsene mai. E lei naturalmente essendo insegnante di lingue estere non mi voleva smentire di questo fatto. Per ore dunque curava il ripasso delle mie cognizioni grammaticali entrambi comodamente seduti in un giardino forse non più adesso esistente della mia città. Io potevo anche dirle enormi strafalcionerie senza che lei si prendesse d’impazienza o gridasse per la grande comprensione del suo spirito. Nè passava giorno o due che non giungessi io al luogo dove sapevo trovarla ossia giardino pubblico ma non troppo frequentato recandole tra le mani un mazzo di fiori. Vuoi primule con reseda vuoi rose con altri contorni significanti cioè rispettivamente gioventù con dolcezza e beltà con altri pregi. E lei replicava a me spesso con offerte d’edera significante amicizia quando non con mammole significanti ma per scherzo s’intende pudore di modestia. Si può comprendere senza sforzo con quale trepidazione ogni dì mi incamminassi a detto luogo voglioso di ripassare lezioni eppure tanto pesanti per me. Ma per via c’era un vecchio simulante mendicità onde accrescere le sue ricchezze già nascoste il quale costui al vedermi con fiori nelle mani irrideva forte sempre...
Bibbia/Guizzardi/p.175

 Io leggo ora questo splendore... Anche le notifiche lo boicottano. Ma lui vola sopra e sa che prima o poi qualcuno vince la gravità e lo riacciuffa:)
Io leggo ora questo splendore... Anche le notifiche lo boicottano. Ma lui vola sopra e sa che prima o poi qualcuno vince la gravità e lo riacciuffa:)
Brava che l’hai riacciuffato!
Cosa vuoi che gli faccia la mancata notifica. Da come me lo immagino credo se la rida molto sia di chi lo venera sia di chi lo boicotta :)
Ritornarci con Guizzardi è un esercizio alla Buster Keaton, finirò in un ruzzolone dritta nella banda dei sospiri.
Cosa vuoi che gli faccia la mancata notifica. Da come me lo immagino credo se la rida molto sia di chi lo venera sia di chi lo boicotta :)
Ritornarci con Guizzardi è un esercizio alla Buster Keaton, finirò in un ruzzolone dritta nella banda dei sospiri.
 Ti seguo, mi guarda da troppo tempo. Il cronoprogramma di Infinite jest andrà un attimo a bagno, ma pazienza
Ti seguo, mi guarda da troppo tempo. Il cronoprogramma di Infinite jest andrà un attimo a bagno, ma pazienza
tanto Infinite Jest è abituato, è il suo destino...
con tanto di vaso di fiori che vola :)
Ripreso in mano e riletto a tratti, un libro curioso pieno di aneddoti e ritratti, da Manganelli a Calvino a Ingeborg Bachmann.
Lascio il brano su Manganelli: Dio, le cene, le scatolette.
Mela Zeta di Ginevra Bompiani
Un giorno, parlando con Giorgio Manganelli al telefono, sede principale della nostra amicizia, arrivammo a un punto cruciale. Parlavamo di Dio. Io dissi qualcosa come: “E se Dio fosse il non linguistico?” Lui mi fermò: “Questa conversazione deve continuare faccia a faccia”. E mi diede appuntamento l’indomani alle sei di sera a casa mia. Come sempre fu puntuale. Come sempre io ero agitata e lui torvo. Sedette sul divano e io di fronte, nella grande sedia indonesiana con lo schienale a ruota. Non accadde niente. Nessuno dei due sapeva riprendere la conversazione dove l’avevamo lasciata e tanto meno proseguirla. Parlare con Manganelli richiedeva una preparazione chimica particolare. A quell’ora non eravamo preparati. Non dicemmo niente. Se ne andò piú torvo di com’era arrivato e Dio fluttuò fra linguistico e non linguistico verso il crepuscolo.
Ci eravamo conosciuti a Lerici, alla festa che mio padre diede nella villa sul mare per salutare la nascita del Gruppo 63. Di quella festa ricordo solo lui.
Lo ritrovai a Roma. Stavamo cercando casa, anzi case, io e quell’altro Giorgio. Manganelli lasciava la sua in piazza delle Coppelle. La prese l’altro Giorgio. Ci furono tacite liti perché Manganelli, allora poverissimo e spaventatissimo, avendo fatto il salto mortale dall’università al giornalismo, per portarsi via le lampadine tagliò i fili. I due Giorgio litigavano in contumacia, mentre io uscivo la sera con Manganelli.
Le nostre cene erano insieme abituali e straordinarie. Ognuna era preceduta da lunghi parlamentari. A volte ci voleva un anno per mettersi d’accordo, a volte bastavano due giorni; qualche volta, dopo aver escluso ogni possibilità, ritelefonava proponendo la sera seguente.
L’ora non doveva essere tarda, le sette e tre quarti. Avevo il terrore di arrivare in ritardo. Ma nemmeno la puntualità era sufficiente: una sera, arrivando affannata alle 7:46, lo trovai che camminava ferocemente davanti al ristorante e vedendomi mi disse: “Credevo che non venissi piú”. Una volta la tensione si trasmise all’automobile che si ruppe facendomi tardare. Tornai a casa, aspettai le sette e tre quarti, telefonai al ristorante e dissi: “Mi chiami il signore che sta entrando in questo momento”. Rendeva l’aria cosí elettrica che non mi sorpresi la sera che ci fu il terremoto. Le cene, come ogni altra cosa, seguivano rituali di acciaio: quando veniva a casa, arrivava alle otto meno un quarto e andava messo subito a tavola. Accanto al suo posto c’era già un piattino di peperoncini per ingannare l’attesa e dargli il coraggio di masticare. Il cibo doveva essere grasso, abbondante e sugoso. Il vino, all’altezza. Alle nove si precipitava giú dalle scale per telefonarmi subito dopo.
Il Giorgio con cui vivevo doveva uscire a cena le sere in cui veniva Manganelli, finché un giorno ebbi il coraggio di ribellarmi. Lo convinsi a permettere che si fermasse a mangiare con noi. Tra la prima e la seconda portata sgusciai in cucina. Uscendo dalla stanza, sentii un terribile silenzio congiungersi alle mie spalle. Tornai indietro e udii Manganelli chiedere gravemente al suo omonimo: “E lei va a caccia signor Giorgio?”
La timidezza, mascherata di grottesco, di buffonesco, di aulico, di collerico, era forse la sua dote piú acuta. Nei ristoranti, data l’ora, eravamo quasi sempre soli. Andavamo spesso al Romagnolo, vicino al Pantheon, una grande sala quadrata, noi due seduti a un tavolo d’angolo, uno sparuto commensale all’altro capo. “Credi che quello là mi sente masticare?” chiedeva cautamente.
In quel periodo, pur vedendoci abbastanza poco, ci sentivamo spesso. Le difficoltà della presenza svanivano al telefono. Perciò quello fu il luogo privilegiato della nostra amicizia. Mi chiamava per lo piú fra le otto e le otto e un quarto del mattino, prima che cominciasse la giornata, per lo meno la mia. La telefonata conteneva di solito qualche insulto. Era bravissimo a insultare. Ti insultava come una regina. Durante la conversazione avveniva una tacita sfida: cambiare l’umore dell’altro. Il suo era spesso depresso o incollerito. Se avevo successo, verso la fine sorrideva. E poco dopo richiamava. A volte ero io di malumore e se ne accorgeva prima di me. Stanava il malumore dal suo nascondiglio, lo portava a galla. Io poi non riuscivo piú a liberarmene. Al terzo giorno mi lamentai. Me lo aveva buttato addosso e ora doveva togliermelo, come un mantello di Nesso. Mi disse: “Sei ingiustamente infelice per non assumerti l’infelicità che ti spetta.
Erano telefonate lunghe, interessanti, a volte sconvolgenti. Usava parole che conosceva solo lui. Una di queste l’ho cercata a lungo dopo la sua morte: indicava la tattica canina di buttarsi a pancia all’aria davanti al nemico per disinnescarne l’aggressività, fingendosi un cucciolo; tattica spesso usata dagli umani, specialmente dalle donne. Ho interrogato diverse sue amanti, ma nessuna se la ricordava.
Quando Calvino venne a stare a Roma, volle incontrarlo e mi chiese di combinare una cena. Uno dei miei tanti rimpianti è di non averlo fatto. Stavo a Roma pochi giorni alla settimana e quel continuo andirivieni mi confondeva, insieme alle consuete difficoltà di organizzare qualcosa con Manganelli. Finalmente Chichita Calvino si decise a farlo da sola. Invitò Manganelli con Luigi e Anna Malerba. Fu un disastro. Manganelli arrivò molto prima degli altri, voleva mangiare subito, cenò da solo, servito dagli attoniti Calvino e se ne andò sgarbatissimo prima che gli altri si mettessero a tavola.
Perché ci siamo persi di vista? Forse perché stavo in campagna e venivo di rado a Roma, forse perché mi sono impigrita di fronte a tutte le difficoltà. Forse perché lo spreco è una costante della mia vita.
Non della sua. Una sera mi invitò a cena a casa. Trovai il banco della cucina lindo e intatto, coperto di scatolette nuove, ancora sigillate con l’etichetta del prezzo. Mi fece aprire quelle di cui mi sarei servita per la cena. Le altre aspettarono le loro occasioni.

Lascio il brano su Manganelli: Dio, le cene, le scatolette.
Mela Zeta di Ginevra Bompiani
Un giorno, parlando con Giorgio Manganelli al telefono, sede principale della nostra amicizia, arrivammo a un punto cruciale. Parlavamo di Dio. Io dissi qualcosa come: “E se Dio fosse il non linguistico?” Lui mi fermò: “Questa conversazione deve continuare faccia a faccia”. E mi diede appuntamento l’indomani alle sei di sera a casa mia. Come sempre fu puntuale. Come sempre io ero agitata e lui torvo. Sedette sul divano e io di fronte, nella grande sedia indonesiana con lo schienale a ruota. Non accadde niente. Nessuno dei due sapeva riprendere la conversazione dove l’avevamo lasciata e tanto meno proseguirla. Parlare con Manganelli richiedeva una preparazione chimica particolare. A quell’ora non eravamo preparati. Non dicemmo niente. Se ne andò piú torvo di com’era arrivato e Dio fluttuò fra linguistico e non linguistico verso il crepuscolo.
Ci eravamo conosciuti a Lerici, alla festa che mio padre diede nella villa sul mare per salutare la nascita del Gruppo 63. Di quella festa ricordo solo lui.
Lo ritrovai a Roma. Stavamo cercando casa, anzi case, io e quell’altro Giorgio. Manganelli lasciava la sua in piazza delle Coppelle. La prese l’altro Giorgio. Ci furono tacite liti perché Manganelli, allora poverissimo e spaventatissimo, avendo fatto il salto mortale dall’università al giornalismo, per portarsi via le lampadine tagliò i fili. I due Giorgio litigavano in contumacia, mentre io uscivo la sera con Manganelli.
Le nostre cene erano insieme abituali e straordinarie. Ognuna era preceduta da lunghi parlamentari. A volte ci voleva un anno per mettersi d’accordo, a volte bastavano due giorni; qualche volta, dopo aver escluso ogni possibilità, ritelefonava proponendo la sera seguente.
L’ora non doveva essere tarda, le sette e tre quarti. Avevo il terrore di arrivare in ritardo. Ma nemmeno la puntualità era sufficiente: una sera, arrivando affannata alle 7:46, lo trovai che camminava ferocemente davanti al ristorante e vedendomi mi disse: “Credevo che non venissi piú”. Una volta la tensione si trasmise all’automobile che si ruppe facendomi tardare. Tornai a casa, aspettai le sette e tre quarti, telefonai al ristorante e dissi: “Mi chiami il signore che sta entrando in questo momento”. Rendeva l’aria cosí elettrica che non mi sorpresi la sera che ci fu il terremoto. Le cene, come ogni altra cosa, seguivano rituali di acciaio: quando veniva a casa, arrivava alle otto meno un quarto e andava messo subito a tavola. Accanto al suo posto c’era già un piattino di peperoncini per ingannare l’attesa e dargli il coraggio di masticare. Il cibo doveva essere grasso, abbondante e sugoso. Il vino, all’altezza. Alle nove si precipitava giú dalle scale per telefonarmi subito dopo.
Il Giorgio con cui vivevo doveva uscire a cena le sere in cui veniva Manganelli, finché un giorno ebbi il coraggio di ribellarmi. Lo convinsi a permettere che si fermasse a mangiare con noi. Tra la prima e la seconda portata sgusciai in cucina. Uscendo dalla stanza, sentii un terribile silenzio congiungersi alle mie spalle. Tornai indietro e udii Manganelli chiedere gravemente al suo omonimo: “E lei va a caccia signor Giorgio?”
La timidezza, mascherata di grottesco, di buffonesco, di aulico, di collerico, era forse la sua dote piú acuta. Nei ristoranti, data l’ora, eravamo quasi sempre soli. Andavamo spesso al Romagnolo, vicino al Pantheon, una grande sala quadrata, noi due seduti a un tavolo d’angolo, uno sparuto commensale all’altro capo. “Credi che quello là mi sente masticare?” chiedeva cautamente.
In quel periodo, pur vedendoci abbastanza poco, ci sentivamo spesso. Le difficoltà della presenza svanivano al telefono. Perciò quello fu il luogo privilegiato della nostra amicizia. Mi chiamava per lo piú fra le otto e le otto e un quarto del mattino, prima che cominciasse la giornata, per lo meno la mia. La telefonata conteneva di solito qualche insulto. Era bravissimo a insultare. Ti insultava come una regina. Durante la conversazione avveniva una tacita sfida: cambiare l’umore dell’altro. Il suo era spesso depresso o incollerito. Se avevo successo, verso la fine sorrideva. E poco dopo richiamava. A volte ero io di malumore e se ne accorgeva prima di me. Stanava il malumore dal suo nascondiglio, lo portava a galla. Io poi non riuscivo piú a liberarmene. Al terzo giorno mi lamentai. Me lo aveva buttato addosso e ora doveva togliermelo, come un mantello di Nesso. Mi disse: “Sei ingiustamente infelice per non assumerti l’infelicità che ti spetta.
Erano telefonate lunghe, interessanti, a volte sconvolgenti. Usava parole che conosceva solo lui. Una di queste l’ho cercata a lungo dopo la sua morte: indicava la tattica canina di buttarsi a pancia all’aria davanti al nemico per disinnescarne l’aggressività, fingendosi un cucciolo; tattica spesso usata dagli umani, specialmente dalle donne. Ho interrogato diverse sue amanti, ma nessuna se la ricordava.
Quando Calvino venne a stare a Roma, volle incontrarlo e mi chiese di combinare una cena. Uno dei miei tanti rimpianti è di non averlo fatto. Stavo a Roma pochi giorni alla settimana e quel continuo andirivieni mi confondeva, insieme alle consuete difficoltà di organizzare qualcosa con Manganelli. Finalmente Chichita Calvino si decise a farlo da sola. Invitò Manganelli con Luigi e Anna Malerba. Fu un disastro. Manganelli arrivò molto prima degli altri, voleva mangiare subito, cenò da solo, servito dagli attoniti Calvino e se ne andò sgarbatissimo prima che gli altri si mettessero a tavola.
Perché ci siamo persi di vista? Forse perché stavo in campagna e venivo di rado a Roma, forse perché mi sono impigrita di fronte a tutte le difficoltà. Forse perché lo spreco è una costante della mia vita.
Non della sua. Una sera mi invitò a cena a casa. Trovai il banco della cucina lindo e intatto, coperto di scatolette nuove, ancora sigillate con l’etichetta del prezzo. Mi fece aprire quelle di cui mi sarei servita per la cena. Le altre aspettarono le loro occasioni.




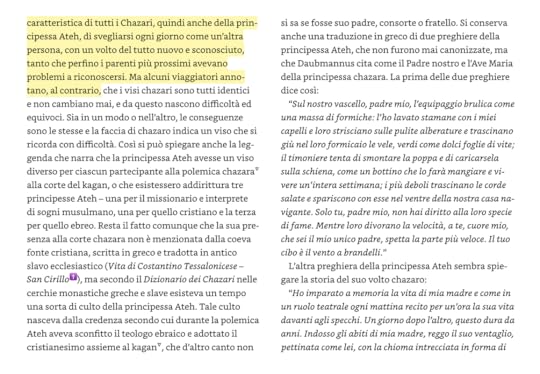



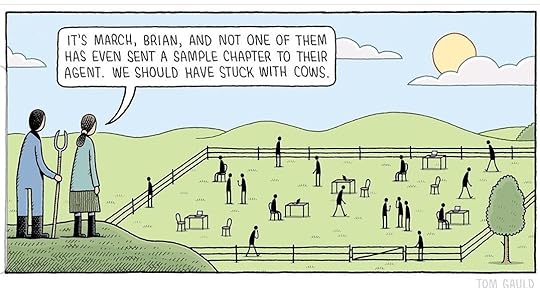


(citazioni, pensieri, consigli)