Roberta Conte's Blog
October 2, 2020
Medea, o sull’uccisione del figlio
Per scrivere bisogna leggere. Credo sia una delle prime lezioni alle elementari.
Per scrivere bisogna leggere. Bisogna addentrarsi nelle parole, carpirne il significato più evidente e quello più nascosto (tutte le parole, nessuna esclusa, hanno sempre un significato estrinseco e uno intrinseco), rivoltarle, rimescolarle, appropriarsene.
Nell’epoca dei follower, dei mi piace, delle visualizzazioni, non è di tendenza abbandonare per un po’ il proprio blog o il proprio profilo. La macchina dei mi piace ci impone di pubblicare quotidianamente e a ore ben precise, ma per scrivere bisogna leggere.
E leggere richiede tempo, un tempo lungo, disteso in cui, come si diceva, appropriarsi delle parole, diventare intimi con esse instaurando una relazione col testo che richiede il suo percorso specifico per essere davvero compreso.
I grandi malintesi che sembrano più frequentemente affiorare fra le persone sono dovuti proprio a questa mancanza di tempo. Quando riceviamo un torto, una parola sbagliata, contrattacchiamo senza darci il giusto tempo per metabolizzare e capire cosa ci è stato detto, come e perché.
La lettura insegna questo, a donarsi uno spazio temporale in cui misuro le parole, i gesti e le emozioni. Est modus in rebus, dicevano i latini. C’è una misura nelle cose. Misura che stiamo perdendo nella corsa multimediale che il rinnovamento tecnologico, di cui siamo, parte ci impone.
Quindi mi sono presa il mio tempo e ho letto le storie dei miti raccontate da Giorgio Ieranò, nei suoi due testi Eroi e Olympos. Mi sono immersa in un tempo antico che mi ha dato gli strumenti per leggere il nostro tempo moderno.
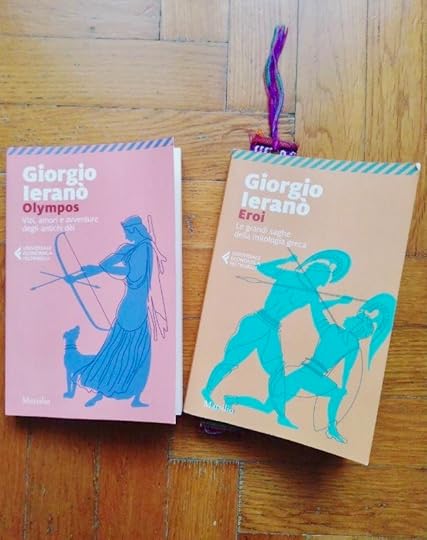
I racconti sono diversi e narrano delle figure a noi familiari di Orfeo, Medea, Minosse, Teseo, Achille e degli dei dell’Olimpo. Ritorniamo leggendo ai tempi degli amori fra dei e mortali, della guerra di Troia, dei sacrifici che si è disposti a compiere per amore, ma una storia ha toccato particolarmente le mie corde che hanno vibrato nello scoprire un dettaglio del mito di cui non ero a conoscenza.
A tutti è nota la storia di Medea, la strega, la diversa, la moglie tradita e abbandonata, l’omicida dei suoi stessi figli. Ancora oggi quando al telegiornale arriva l’ennesima notizia di una madre che uccide i suoi figli si sente parlare della “sindrome di Medea”.
Gli stessi greci rabbrividivano al sentire la sua storia, all’idea che una madre sia capace di uccidere le creature che ha portato in grembo. Medea diventa protagonista di una «storia che tutti cercano di dimenticare, come se non fosse mai avvenuta».
Ma c’è un altro atto oscuro che macchia le mani di Medea, un altro infanticidio, quello di suo fratello neonato.
«Dicono infatti che Medea non si sia limitata a tradire il padre. Ancora prima di fuggire dalla reggia avrebbe preso dalla sua culla il piccolo Apsirto, il fratellino ancora infante. Quando le navi di Eeta braccavano da presso l’Argo, Medea sarebbe salita sul ponte della nave: con un coltello avrebbe sgozzato e poi fatto a pezzi il fratello bambino. Poi avrebbe gettato i brandelli di carne in mare, costringendo il padre Eeta a fermarsi per ricomporre il corpo straziato di quel figlioletto infelice e innocente.»
L’innocenza di Apsirto non ferma Medea da questo atroce gesto, parte di una vicenda oscura che gli stessi antichi raccontano in maniera diversa, forse perché «essi stessi a disagio di fronte a un delitto così orrendo».
Quante volte noi vediamo frantumarsi l’innocenza di una vita? Magari in una stanza di ospedale, in una clinica abortista, nel bagno di casa? Quante vite innocenti si sono spente? E quante volte la sacralità della vita è stata calpestata sia che si tratti di un bambino nato o di un bambino nel grembo della madre?
Troppe volte abbiamo urlato lo scandalo per la Medea dei nostri giorni che uccide i suoi figli e troppe poche volte abbiamo taciuto il dolore per la Medea che uccide i suoi figli nel grembo, accecati dalla volontà distorta di volerne a tutti i costi cogliere la differenza, mentre un bambino nato è degno di vivere e dunque è gesto orribile ucciderlo, e un bambino non nato è altrettanto degno di vivere e dunque è gesto orribile ucciderlo.
Viviamo, come direbbe Chesterton, in un «mondo che conosce il prezzo di tutto, ma che ignora il valore delle cose». Siamo stati lentamente e senza percezione paralizzati da una società del consumo che vieta anche la più piccola possibilità di riconoscimento della bellezza di una vita innocente. Allora va bene la morte (declinata nell’aborto o nell’eutanasia) perché la vita non è più sacra.
Va bene sacrificare sull’altare della libertà di espressione, di essere, di sentimenti, ogni forma di meraviglia, di miracolo, di vero nel reale. Se è questo lo scenario, il mondo va salvato proprio con tutto quello che il mondo stesso abortisce: una Bellezza che si mescoli alla Verità.
Lo diceva Keats: «bellezza e verità sono una cosa. Questo è quanto sappiamo sulla terra e questo è tutto che sapere importa». Lo sapevano anche i greci che hanno tramandato la storia di Medea.
Donna di emozioni e di magie, me la immagino così alla fine della sua vita: sogna e aspetta che le arrivino ai piedi i suoi piccoli accompagnati dallo zio. Me la immagino sorridere e abbracciarli come se avesse ricevuto il perdono del proprio crimine e non ci fosse altro dolore che ricordare.
August 11, 2020
A ogni sofferenza corrisponde sempre una maggiore quantità d’amore
Delitto e Castigo di Fëdor Dostoevskij
Russia, Pietroburgo. È un’estate calda e afosa, le giornate bagnate dal sudore proprio come le nostre delle ultime settimane. Rodion Romanovič Raskol’nikov è semplicemente uno studente prima di diventare l’assassino di due donne.
L’omicidio premeditato lo fa precipitare nell’angoscia più cupa, suo vero castigo, finché sopraffatto dal dolore per ciò che ha commesso si pente e confessa, iniziando così un secondo castigo in Siberia, vera via di redenzione.
Ragione del pentimento di Rodion è una giovane ragazza, Sonja, che quasi come una terrena Beatrice dantesca, accompagna il protagonista nel tortuoso cammino verso la libertà. Infatti, solo chiamando le cose col loro nome siamo davvero liberi.
Prima del pentimento, Rodion si nasconde dietro le sue paure adducendo ragioni inconsistenti al suo efferato gesto, divenendo prigioniero del suo stesso gesto. Lo avrebbe fatto, lui sostiene, per le giuste ragioni, paragonandosi infine a Napoleone, capace di versare sangue per fare del bene. Sonja gli dona occhi nuovi, dal momento che ogni redenzione passa inevitabilmente dal dono di una vista rinata. Ora Rodion può trovare un senso persino del dolore più grande: la consapevolezza di aver ucciso e la fatica di perdonare sé stessi.
A nessuno sono estranee situazioni dolorose che pongono nella condizione di dover rinunciare a qualcosa di noto per abbracciare l’ignoto. In questo vacillare però, non è forse Dio che ci chiede di compiere un semplice gesto d’amore? Che ci sta dicendo: “Fidati, in quello che chiami ignoto troverai solo Amore”. Quell’amore gratuito che hai sempre desiderato e che spesso è mancato. Quell’amore che devi ricevere e che devi donare.
A ogni sofferenza che Dio ci dona corrisponde sempre una quantità maggiore di amore. Quell’Amore che salva.
“Perché no, anche la sofferenza può essere una buona cosa. Allora soffrite! […] Lo so che non vi va di crederci, ma non state a sofisticare maliziosamente; lasciatevi andare alla vita, così, senza stare a ragionare; non preoccupatevi, vi trarrà dritto alla riva e vi metterà in piedi. A quale riva? E come faccio a saperlo? Io credo solo che abbiate ancora molto da vivere. […] che ne sapete, forse Dio vi riserva per qualcos’altro. E voi abbiate un cuore grande, e un po’ meno paura. Vi manca il coraggio per una grande realizzazione futura? No, in questo caso è vergognoso non aver coraggio. Una volta che avete fatto il passo che avete fatto, dovete aver animo. Ora è questione di giustizia. Ecco, fate quello che esige la giustizia. Lo so che non mi credete, ma, diamine, la vita vi trarrà in salvo.”
Sono le parole di Porfirij Petrovič, il giudice istruttore incaricato di risolvere gli omicidi e che insieme a Sonja porterà Rodion alla confessione.
La vita vi trarrà in salvo, dice Porfirij. Solo l’Amore salva, si canta. Anche quando sembra non esserci speranza, né la sofferenza né il peccato possono dire l’ultima parola sulla nostra vita, togliere dignità alla vita. L’omicidio è stato compiuto per l’incapacità di Rodion di percepire e amare questa dignità. Sonja dirada la nebbia che impedisce all’uomo di vedere.
[Rodion] Ma dopotutto ho ucciso solo un pidocchio, Sonja, solo un inutile, ripugnante, nocivo pidocchio!
[Sonja] Ma come può una creatura umana essere un pidocchio!
La piccolezza del nostro essere, se ci pensiamo davvero paragonabile a un pidocchio nell’universo, è degna perché dono. Anche quando questo dono è macchiato dal peccato, non perde valore se volgiamo il nostro cuore al perdono.
Le nostre peggiori storie hanno sempre una misteriosa apertura al cielo e alla salvezza. Spesso non ce ne accorgiamo, ma è proprio questa la consistenza della nostra speranza.
August 4, 2020
La vita davanti a noi
La vita davanti a sé di Romain Gary
«Signor Hamil, si può vivere senza amore?»
«Sì» ha detto, e ha abbassato la testa come se si vergognasse.
Questa è la domanda che Momò, un bambino cresciuto da Madame Rosa in un appartamento al sesto piano di un palazzo nel quartiere multietnico di Belleville a Parigi, chiede due volte di seguito al signor Hamil.
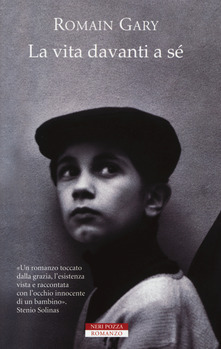 Fonte Ibs.it
Fonte Ibs.itSi può vivere senza amore?
La risposta del signor Hamil è chiaramente una bugia. Scrivo chiaramente, ma dimentico che non per tutti è così. Spesso si infiltra in testa il velenoso pensiero secondo il quale solo se degna la vita può essere vissuta, omettendo (forse volontariamente) che solo l’Amore salva: la vita equivale alla presenza dell’Amore.
Perché dico volontariamente? Perché volontariamente il signor Hamil mente. Forse quest’uomo ha avuto un’infanzia infelice? Forse i suoi genitori non l’hanno amato? Forse non è riuscito ad amare a sua volta? Questo non lo sappiamo, il libro non lo rivela. Solo la vergogna che prova («ha abbassato la testa come se si vergognasse») ci fa intuire che qualcosa di doloroso è presento nel dentro di questa vita: «è sempre negli occhi che la gente è più triste.»
Sappiamo qualcosa di Momò. Il bambino non conoscerà mai l’amore dei suoi genitori e va elemosinando questo affetto ovunque e da chiunque. L’amore unico e vero, quello dei propri genitori, manca nella vita di Momò.
Se la presenza dell’Amore equivale alla vita, laddove manca amore per la vita, ecco che la morte prende posto, accolta non come estrema compagna di viaggio, ma come sollievo alla sofferenza, palliativo di una vita che non appare più degna di essere vissuta.
Madame Rosa è una donna anziana, sta molto male, è sola, e decide di non andare in ospedale dove la farebbero «vivere come un vegetale» e non la «vogliono abortire». Sceglie di salutare questo mondo nella cantina di casa sua dove non possono trovarla.
Madame Rosa non vede la grazia nella vecchiaia, nella sofferenza un’occasione di redenzione. Fugge dalla vita attraverso una sorta di “eutanasia”: si lascia morire in casa.
Cosa può dirci oggi di questa storia?
Mi ha molto colpito la vicenda della donna suicidatasi a Crema dandosi fuoco, sotto le videocamere fredde dei cellulari di spettatori apatici. In che modo l’empatia verso questa donna è stata divorata dal desiderio di filmare la tragedia in atto?
La risposta è chiara. Applicare un paradigma di valore alla vita, secondo il quale solo un’esistenza degna può essere vissuta, ha svalutato la vita stessa. Se poi con l’aggettivo degna intendiamo priva di sofferenza partiremmo per una ricerca senza fine. Quale vita non è toccata dalla sofferenza?
Lo sa bene Momò, alter ego dell’autore Romain Gary, che la vita a volte può essere ingiusta, può toglierti tutto, può mancare l’amore dei nostri cari, ma tutto trova senso quando viviamo nell’Amore che salva. Quando riusciamo a vedere il dono della vita davanti a noi.
August 3, 2020
Vasta come un mare azzurro, la poesia. Azzurropoesia
Cosa scrivere quando bisogna presentarsi?
A questa domanda facilmente ci colpisce la sindrome da pagina bianca. Una sindrome voluta, se ci pensiamo bene, dal momento che rivelarsi a poco a poco ad altri è sempre un’impresa ostica che mette in gioco tutto il nostro essere.
Cosa posso dire allora di me? Mi chiamo Roberta, sono un’insegnante, una scrittrice ma soprattutto una donna. Cerco attraverso le parole il senso del Creato che mi è stato donato e, in questo viaggio, la poesia mi assiste come una guida fedele.
La poesia è una parola che tutti abbiamo dentro. Tutti siamo un po’ poeti. Tutti siamo narratori delle parole del cuore. La differenza nasce nel decidere di mettere o meno i nostri versi sulla carta.
Quante volte ci sarà capitato di cogliere la bellezza nel mondo circostante, la meraviglia dentro di noi. Senza saperlo in quel momento stavamo creando poesia, stavamo donando a noi stessi occhi nuovi. La poesia dona sempre uno sguardo di luce: rinnovatrice per natura, rende bello il nuovo, prezioso il vecchio.
Nell’aprile del 2019 ho pubblicato la mia prima raccolta poetica dal titolo Anthoi, ovvero “fiori” in greco antico. Nome dal significato così semplice e così profondo: la parola greca anthologhìa, che traduciamo con “raccolta di fiori” o “scelta di fiori”, sprigiona tutto il suo potente significato. Cosa sono le poesie, le parole messe su carta, se non fiori raccolti da un vasto prato che è la nostra memoria e il nostro genio creativo?
Viviamo in un momento storico in cui la vita è attaccata su più fronti, resistente rosa nella bufera di venti contrari.
Mi sono chiesta “cosa posso fare?”, “come posso aiutare?”, “io scrivo, ma per chi scrivo?”, “quale lo scopo?”. Ho risposto a queste domande con la poesia nascosta in ogni luogo e che bisogna cercare come seguendo un imperativo. La letteratura conserva i più alti e coraggiosi inni alla vita, basta sapere dove andare a cercare e leggerli con occhi nuovi.
Io ho solo questo in mano, un computer (una volta, foglio di carta) e dei libri, letti e che leggerò. Questo offro, raccogliendo quello che scrivo come se pescassi nella vastità dell’oceano, perché se la poesia è ovunque e in ognuno, vasta come un mare azzurro è la poesia. Azzurro poesia.
Il vero amore è lo sguardo fisso sull’altro
Ho capito per la prima volta il vero significato della parola sguardo dopo aver concluso il mio primo giorno in classe da insegnante.
Fino a due mesi prima dall’inizio del mio incarico a scuola ero semplicemente una studentessa appassionata di musica, arte e poesia. Cercavo, e cerco, nelle parole l’ordine delle cose, la chiave del senso. Pensavo che lo sguardo fosse un gesto che gli altri dovevano porre su di me (uso appositamente il verbo dovere), per dar senso alla mia vita, per sentirmi definire con una parola tanto agognata: “bravissima!”.
In fondo è ciò che ogni studente (anzi ognuno di noi) vuole, sia lo studente cosiddetto modello, sia lo studente menefreghista. Entrambi vogliono sentire quella parola (“bravissimo!”), perché entrambi sono facce di una stessa medaglia. Non conta il risultato del proprio impegno o del proprio qualunquismo. Ogni studente vuole essere visto, definito, vuole sentire su di sé lo sguardo di chi ha promesso di guidarlo: l’adulto.
Il passaggio da studente a insegnante ha coinciso nel mio cammino con quello da ragazza a donna adulta. Quando studiavo pensavo giustamente ai miei traguardi, a raggiungere i miei successi e conservavo stretto uno sguardo concentrato su me stessa. Se ci riflettiamo, è ciò che ognuno fa, almeno fino a quando continua il suo percorso di studi o finché non si è realizzato in qualche modo. La propria prospettiva tocca soltanto l’orizzonte dell’autorealizzazione.
L’arrivo del lavoro ci trasforma. Nell’insegnamento, come in altre professioni che toccano l’umano nella sua essenza, ancora di più. La responsabilità che adesso appare così strettamente legata a ogni nostra singola azione (come invece non lo era prima) ci fa percepire il peso e l’importanza delle nostre scelte: ci fa essere in una parola adulti.
Entrata in classe avevo nelle mani, per la prima volta, la vita di qualcun’altro. Di una ventina di bambini che dipendevano in tutto da me in quelle ore trascorse insieme, la cui crescita scolastica sarebbe dipesa da me, i cui sconforti e le cui soddisfazioni sarebbero dipesi da me.
Come potevo reggere questo peso?
Ho trovato il segreto nello sguardo. Se il bambino si sente amato e apprezzato allora prende il volo. Se percepisce il rispetto da parte dell’adulto, e attraverso il confronto con lui si conosce e si riconosce, al fine di evidenziare la propria unicità e le proprie diversità, allora il bambino impara.
Tutto questo avviene solo tramite lo sguardo, che non deve essere un semplice guardare, ma deve tramutarsi in uno sguardo amante che guarisce e purifica.
Lo scriveva Dante che lo studio «è applicazione dell’animo innamorato della cosa a quella cosa stessa». Ma quando può l’animo innamorarsi? Quando ancor prima l’insegnante è innamorato del lavoro che fa e delle persone a cui insegna.
Ho intuito nella relazione fra le mura di una classe che anche quando un ragazzo ti sfida e sembra voler mettere in discussione la tua autorità, in realtà sta lasciando nelle tue mani e in tutta la sua concretezza, il suo cuore. Ti sta chiedendo: «tu che hai capito come si fa, amami per quello che sono». L’accettazione nei pregi e nei difetti è tutto ciò che a conti fatti chiediamo a chi amiamo. Lo sguardo permette di sentirci amati e imparare ad amare a nostra volta. Come ancor da principio lo sguardo del Padre su di noi ci permette di leggere in noi stessi e poi accogliere l’altro.
Quanto sono dolci gli sguardi fra due amanti. Quanto sono severi gli sguardi negli occhi di chi si odia.
La prima cosa che si perde tra due persone che non si stimano più e che non condividono più un affetto è proprio lo sguardo. Il contatto visivo svela la nostra anima e siamo in grado di farlo solo con le persone che amiamo.
Il bambino, il ragazzo, che si sente amato cresce e impara perché percepisce il suo valore, si sente degno di una relazione. Con questa costruisce il suo sé e la sua storia, se è vero che l’uomo è davvero uomo solo nella relazione con l’altro. Lo sguardo dell’adulto posto sul giovane aiuta infine quest’ultimo a orientare il suo di sguardo al di fuori di sé. E così avviene l’educazione che è il fine ultimo del mio lavoro. Per dirla con Plutarco, lo scopo primario dell’insegnante non è quello, istruendo, di riempire vasi vuoti, ma di accendere fuochi («la mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere»).
Educando, dopo essere stata educata, e dimentica di me stessa, ho capito che il vero amore è lo sguardo fisso sull’altro. Grazie a Chi ha posto su di me il primo sguardo amante e a chi ha scelto di guardarmi così come sono, ho scoperto la gioia preziosa nascosta nell’amare, più che nell’essere amata. «Dio ha voluto che lo sguardo dell’uomo fosse la sola cosa che non può nascondere» (Alexandre Dumas padre), perché è attraverso di esso che noi davvero amiamo e davvero costruiamo per la nostra realizzazione, ma prima di tutto per quella di chi è stato posto lungo il nostro cammino.



